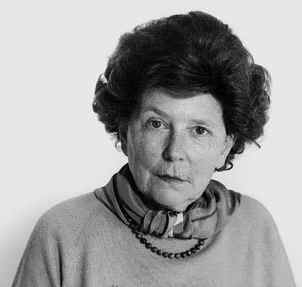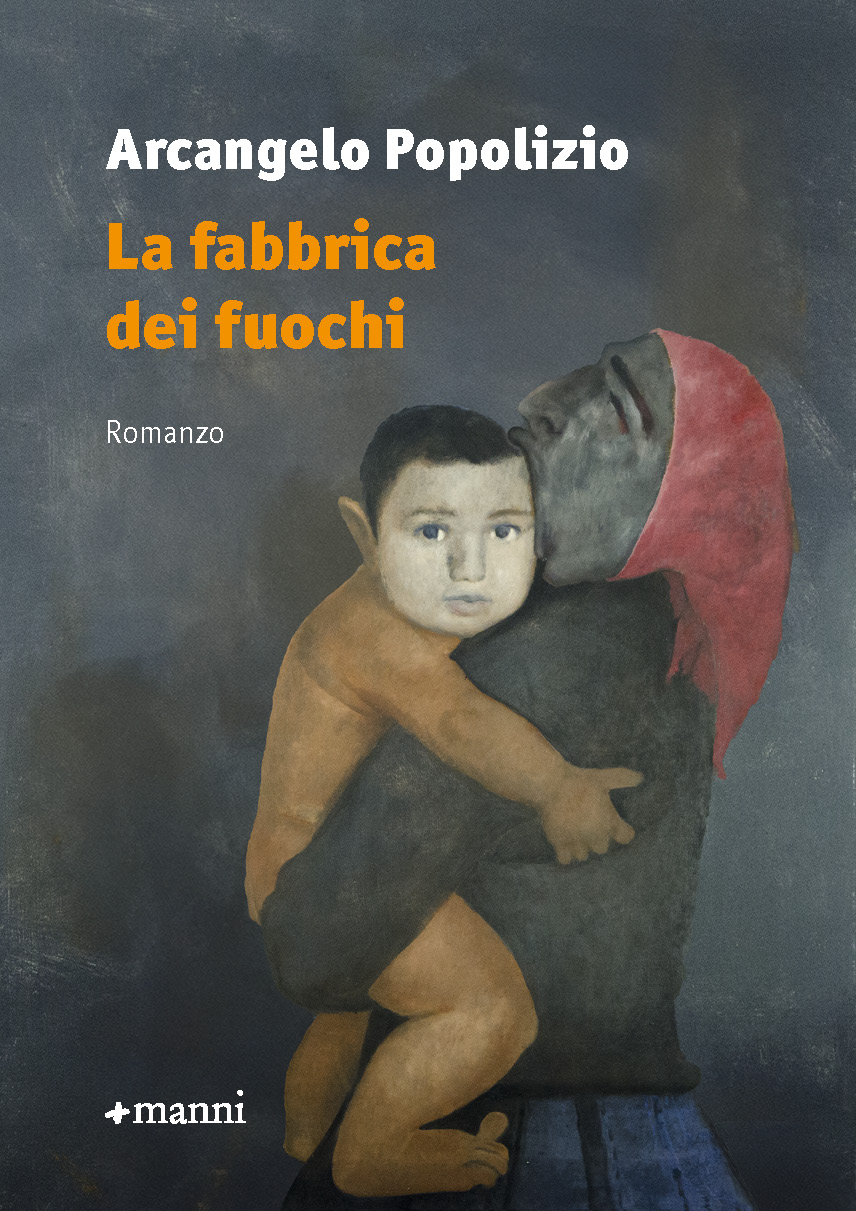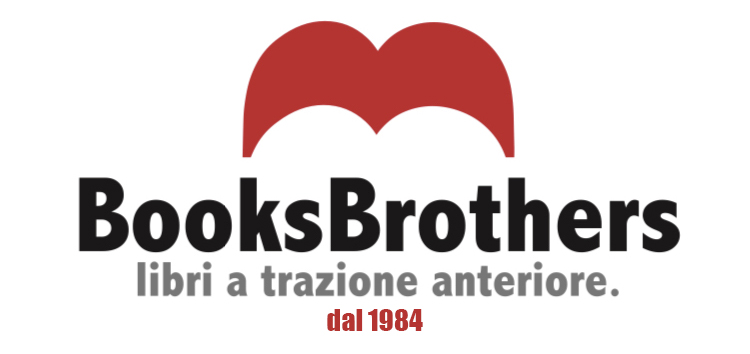Come un esercito fantasma, assedia la nostra civiltà un vuoto sempre più grande. In questo vuoto c’è di tutto: ai due estremi, povertà materiale e povertà morale. Quando esse confliggono accadono tragedie.
Nicola Lagioia, La città dei vivi, pag. 320. È il 3 marzo del 2016. Roma, 4:13 del mattino. Alex Tiburtina (registrato così da Manuel nel suo cellulare) è seduto su una panchina del piazzale della Radio. È messo male, non ha soldi per l’ostello, non sa dove andare a dormire. È stanco, ha bisogno di stendersi su un letto e chiudere gli occhi.
Dice Alex nella sua deposizione: «Sono un bravo ragazzo, la gente finisce che mi aiuta… Ma è molto dura, è frustrante stare in mezzo a una strada quando vieni da una buona famiglia, guardi l’asfalto per ore, senti il silenzio della notte, una cosa distruttiva». E conclude: «Così perdevo tempo nella speranza che accadesse qualcosa».
Alle 4:13 all’improvviso il cellulare si illumina. Chiamate: Manuel rist. Incredibile. Un invito a una festa da parte di una persona che a stento ricordava. In breve, la concreta possibilità di rimediare in qualche modo un divano su cui stendersi e dormire, finalmente.
- Invece in quell’appartamento di via Igino Giordani 2, al Collatino, non c’è alcuna festa ma due giovani uomini, Manuel Foffo e Marco Prato, più o meno della stessa età di Alex, che per diverse ragioni e con ben altre risorse economiche da più di un giorno stanno anch’essi perdendo tempo rimpinzandosi di cocaina e alcol nella speranza che qualcosa accada e poiché nulla accade, sottratto il bancomat ad un amico, s’avvitano in un delirio di onnipotenza («Fino a quando si trattava di parole, tutto si risolveva a una velocità vertiginosa… Le menti dei due ragazzi dialogavano ad alto voltaggio») che li porta a decidere di comprare qualcuno e farne «un oggetto» in balia delle loro pulsioni per vivere un’esperienza «oltre ogni limite», connessa «a un grado elevatissimo di perversione sessuale» (parole della sentenza di condanna).
Alex da quella situazione uscirà indenne. Luca Varani no, sarà massacrato.
Il delitto del Collatino ha riempito a lungo le pagine di cronaca, ora è letteratura. Nicola Lagioia, infatti, ne ha raccontato la storia in un libro nel quale ha dato voce a tutte le persone ma anche ai luoghi in vario modo coinvolti nella vicenda (la casa, la città, il Paese, il tempo che abitiamo). Alla base del lavoro c’è una documentazione poderosa e assolutamente rigorosa. La città dei viviè scandita dalle parole tra virgolette di assassini e vittime, di chi era parte delle loro vite, di chi le ha lambite nell’imminenza del fatto. Ci sono atti giudiziari, deposizioni, dichiarazioni, valutazioni degli inquirenti che hanno indagato, ricostruzioni e commenti dei giornali, materiale raccolto in rete sui social e, soprattutto, in proprio con tanti incontri e interviste.
Ne La città dei vivi Nicola Lagioia ha fatto la cosa più bella e onesta che un autore possa fare: mettere in gioco se stesso cercandosi in quanti per una ragione o l’altra, sbucando da ogni parte, via via affollano il proprio libro. Il male ci interroga. Pag. 383: «Tutti temiamo di vestire i panni della vittima…. Preghiamo Dio o il destino di non farci trovare per strada un assassino. Ma quale ostacolo emotivo dobbiamo superare per immaginare di poter essere noi, un giorno, a vestire i panni del carnefice? È sempre: ti prego, fa’ che non succeda a me. E mai: ti prego, fa’ che non sia io a farlo».
Il delitto del Collatino pone una questione che riguarda tutti: una sorta di deresponsabilizzazione collettiva per cui non riconosciamo più il male dentro di noi fino al punto che molto spesso ormai lo stesso reo non vede la propria colpa. Manuel Foffo e Marco Prado: «Addirittura sembravano non rendersene conto mentre lo facevano… come se ad agire non fossero stati loro ma qualcos’altro, un oscuro regista che aveva preso il sopravvento… “Ma allora sta succedendo davvero”, aveva pensato Manuel quando il massacro era iniziato… Nessuno riusciva più a imputarsi una colpa, nessuno riconosceva a se stesso la possibilità del male».
La riflessione sul libero arbitrio anima da tempo la scrittura di Nicola Lagioia. Già in Riportando tutto a casa (2010) Bari è il correlativo oggettivo di un Paese e un mondo (quello occidentale) che senza più freni inibitori fra i luccichii d’una sfrenata e seducente ricchezza sta per smarrire le proprie virtù e ritrovare accresciuto in modo esponenziale il peggio di sé. Il romanzo, per esempio, comincia con la citazione dello spot della vittoriosa campagna elettorale di Reagan: forse c’è un orso, dicono che sia forte, chissà se è vero, comunque meglio attrezzarsi ed essere forti quanto lui. Il padre del protagonista – che nelle pagine successive s’aggira in Ducato con il figlio fra Bitetto, Triggiano, Capurso e Cellamare per ritirare i tessuti ricamati a mano dalle lavoratrici a domicilio – è, dunque, l’uomo del bosco televisivo a caccia d’una ricchezza che lo faccia essere forte quanto l’orso, sempre che ci sia un orso… Non è più il figlio d’una terra povera fiero d’una vittoria ormai prossima sull’antica miseria, è la declinazione meridionale dell’insensatezza d’un mondo nuovo che è un vuoto fitto di misteri.
Il filo logico della riflessione sull’orso ne La città dei vivi si dipana arrivando al cuore del groviglio morale della contemporaneità. Pag. 375: «Un’ombra ristagnava in noi dalla notte dei tempi. Distruggere il più debole. Oppure indebolire il più forte per poi distruggerlo. L’aggressione come garanzia per la sopravvivenza. Sentirsi impotenti, ridurre l’altro all’impotenza. Sentirsi in pericolo, portare l’altro in pericolo. Sentirsi nulla, ridurre l’altro al nulla. Farsi vincere da questa debolezza, da questa paura atavica, significava scegliere: era qui che andava rintracciata la responsabilità individuale in un’epoca in cui, cerchio retorico dopo cerchio retorico, questo concetto andava nascondendosi sempre più lontano». Per esempio, nell’etologia.
La ferocia, premio Strega 2015, ha forza iconoclasta di abbattimento degli ultimi dei mediterranei. È ambientato in Puglia e racconta la decadenza dei Salvemini, una potente famiglia di costruttori, una sorta di Buddenbrook baresi. Un punto centrale dell’intreccio è una speculazione edilizia sul Gargano. Il romanzo parte come un noir per entrare nella storia e nell’animo dei personaggi e mostrare di ogni vita il cammino delle diverse possibilità, che sono sempre più di una anche se: «Nessuno ha più coscienza delle proprie azioni peggiori. Ci riuscivamo un tempo. Non ci riusciamo più. Soffriamo. Diamo la colpa al meccanismo. Come darla alla natura. Se non c’è scelta, non c’è nemmeno colpa. Fare una cosa in luogo di non farla. Farla.»
L’etologia è una scienza, la letteratura una sfida. La scommessa delle cose strane. Etologia: «…metti una volpe affamata davanti a un branco di conigli. Corri in una piazza piena di colombi e li vedrai volare. Trovami il colombo che non vola». Letteratura: «Non siamo animali, facciamo cose strane». Un romanzo, quando è grande, rende credibile l’assurdo, l’imprevedibile. Etologia: «Facciamo quello che la natura ha deciso per noi. I limiti sono abbastanza chiari». Letteratura: «Ci comportiamo in modo assurdo. Siamo imprevedibili». La forza di un romanzo è rendere credibili azioni contro natura. Innaturali. Un romanzo, quando è grande, interroga le coscienze perché ricorda a chi legge che può sempre scegliere: la ferocia o l’amore.
Un romanzo, quando è grande, riesce a contenere il tutto in una parte, per esempio il mare in un secchiello. Ne La città dei vivi è Roma il secchiello nel quale Nicola Lagioia riversa il mare della complessità morale del nostro tempo. Il tormentato e indissolubile amore che lo lega alla capitale consente all’autore di coglierne quell’umanità profonda nella quale riposa la sua rappresentatività eterna.
Dopo averla lasciata all’improvviso per una nuova e prestigiosa opportunità di lavoro («Ci strappammo da Roma con la cupa soddisfazione di chi si libera da un vizio»), l’autore torna nella sua città d’adozione perché: «… a mancarmi era la certezza, in alcuni momenti vertiginosa, di poter vivere come semplici espressioni umane, alla condizione brada, sciolti dal laccio di uno Stato e perfino dal vincolo di una comunità che voglia dirsi popolo». Il discrimine è la libertà, che può essere «sfascio, anarchia e trascuratezza… disastro» oppure responsabilità consapevolezza, impegno. Tocca scegliere.
San Pietro in Vincoli, Mosè di Michelangelo, quando era a Roma, Sigmund Freud andava ogni giorno in quella chiesa, guardava la statua e si interrogava finché ebbe una rivelazione: «Gli sembrò cioè che Michelangelo scolpendo il suo Mosè, avesse compiuto un poderoso gesto d’arbitrio spingendosi a cambiare la narrazione biblica, documentando ciò che nel Libro non c’è: non l’ira in procinto di esplodere ma l’ira ricomposta. Il Mosè di Michelangelo, secondo Freud, dopo un rapido travaglio interiore, una misteriosa battaglia con se stesso, cambia proposito. Lo sdegno è domato, la violenza si dissolve, il dolore inizia a essere medicato. Il profeta non spezza più le tavole per terra e, proprio per questo, le tavole, cioè la legge, assumono un significato nuovo. Sostituire un narratore con un altro. Che cos’era scattato nella testa di Mosè nell’interpretazione di Freud? E cosa avremmo dovuto fare noi?».
Le vie del male sono infinite. C’è, per esempio, la casualità dell’imponderabile. In un momento di toccante autocritica l’autore ricorda un proprio sconsiderato gesto giovanile che avrebbe potuto avere conseguenze tragiche. Dice il pubblico ministero Francesco Scavo: «Se Marco e Manuel non si fossero incontrati, questo omicidio non sarebbe mai stato commesso». Sostiene Alex: «quella casa trasudava malvagità».
- Al netto della sua irriducibile complessità, resta per noi tutti l’ineludibile urgenza di affrontare il male cambiando narratore perché: «Ci sentivamo in fondo mediocri, stupidi, pavidi, inessenziali, nel crepuscolo di un’epoca che aveva promesso di farci ricchi, intelligenti, coraggiosi. Ci davamo di conseguenza molto da fare per non guardare in faccia la realtà, agitavamo il nostro fallimento spacciandolo per la prova della nostra onestà, della nostra bontà, della nostra lucidità, quando non della nostra purezza, e partivamo a caccia di colpevoli (o iniziavamo a fabbricarceli) pur di tenere in piedi il castello di carte».
Che sia romanzo o inchiesta o altro, La città dei vivi è grande letteratura perché Nicola Lagioia è riuscito a sostituire un narratore con un altro affrontando e domando la violenza per raccontare «l’impatto con il dolore (che) riconsegna la maggior parte di noi a una sorta di innocenza originaria… lasciando intravedere la fragile nudità di specie che ci accomuna tutti». Quest’innocenza originaria è il nuovo narratore che ciascuno di noi deve trovare dentro di sé per affrontare il male e, quando è il momento, scegliere l’amore e non la violenza.
Nicola Lagioia, La città dei vivi, Einaudi, 2020
Nicola Lagioia, La ferocia, Einaudi, 2014