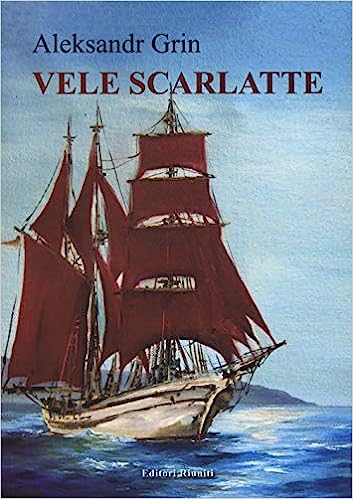È un romanzo ma è una favola… d’amore, quasi un poema. Adesso è anche un film, e proprio grazie ad esso abbiamo scoperto Vele scarlatte di Aleksandr Grin. Pietro Marcello, il regista, ha aggiunto al titolo l’articolo determinativo e fatto qualche adattamento e variante alla storia senza, però, perdere la tenerezza scabra dell’opera ispiratrice.
- Ma cominciamo da lui, Aleksandr Grin: la sua vita è un romanzo. Frase retorica. Più precisamente, nei suoi romanzi Grin ha vissuto col fervore della fantasia la vita che avrebbe voluto vivere nella realtà. E chissà che anche per lui, oltre che per noi suoi lettori, non sia stato meglio così. Altra frase retorica, che sa di puzzoso e dolciastro romanticismo perché non tiene conto della materialità del dolore sofferto dall’autore, a cominciare da quello fisico della fame. Fino a rischio di morte.
Grin nacque nel 1880 a Vjatka, oggi Kirov, una cittadina di provincia «remota e sorda» (definizione dell’autore) sull’omonimo fiume affluente del Kama. Ben presto orfano di madre, Grin ebbe sempre con il padre, ubriacone, un rapporto estremamente difficile, fatto di maltrattamenti, percosse e miseria. Già da ragazzino voleva viaggiare. Sognava il mare. Di fatto fu cacciato da scuola. Andò via da casa adolescente. Fu a Odessa e Bakú. Si arrangiò con lavori occasionali, umili e faticosi. «Passava la notte nell’interno di caldaie vuote, sui moli, sotto le barche rovesciate o semplicemente sotto gli steccati».
Nella nota biografica introduttiva all’edizione Editori Riuniti Konstantin Paustovskij, suo contemporaneo, ci dice anche che «Grin era un uomo straordinariamente magro, alto e curvo, con un viso solcato da mille rughe e cicatrici, con gli occhi stanchi, che si accendevano di un magnifico splendore soltanto nei momenti in cui leggeva o immaginava racconti straordinari… Non era bello ma pieno di fascino nascosto. Camminava pesantemente, come gli scaricatori oppressi dal lavoro. Era pieno di fiducia verso gli altri, e questo si esprimeva esteriormente in una stretta di mano aperta, amichevole. Grin diceva che egli riconosceva gli uomini soprattutto dal modo in cui stringono la mano».
Quando, ancora giovanissimo ma stanco e deluso, va nell’esercito come a un cimitero degli elefanti, proprio allora comincia per lui un’altra vita. A Sebastopoli nel reggimento s’imbatte nei socialisti rivoluzionari. Si infervora. Aderisce al movimento. È un grande oratore, un trascinatore. Nel 1903 viene arrestato, e nei due anni in carcere comincia a scrivere. È la svolta. Lo arrestano una seconda volta ma fugge mentre viene deportato a Tobolsk, nella Siberia occidentale. Arriva stremato a casa e il padre gli procura un documento falso. Con quel nome (Malginov) Grin visse a lungo e firmò anche il suo primo racconto.
Nelle sue memorie scrive che, quando vide quel racconto pubblicato su un giornale, gli tremarono le gambe fino alla paralisi e per la gioia voleva baciare il giornalaio, che lo guardava sospettoso e per come era malmesso non gli credeva. Non gli credette neanche il padre quando qualche anno dopo gli portò il primo libro. Dovette mostrargli i contratti editoriali. Nel frattempo per dedicarsi totalmente alla scrittura aveva lasciato l’impegno militante. Allo scoppio della rivoluzione di febbraio era in Finlandia. Accolse la notizia con entusiasmo e partì a piedi per Pietroburgo.
Nel 1920 era nell’Esercito rosso. Si ammalò di febbre tifoidea. Quando uscì dall’ospedale di Pietroburgo era quasi invalido: «esangue, seminfermo e affamato, soggetto a forti vertigini, vagò giornate intere per la città di granito alla ricerca di cibo e di calore. Era l’epoca delle code, del razionamento, dei lumini a petrolio, delle croste di pane raffermo, delle case gelate. Il pensiero della morte diventava sempre più consueto e sempre più forte». Lo salvò Maksim Gorkij. Lo salvò dalla fame e dalla strada. Lo restituì alla vita. Lo restituì alla scrittura. Gorkij fece in modo che Grin avesse tutto quello che gli occorreva per tornare a sognare con le parole inventando mondi e storie. Pensando a quel che Gorkij aveva fatto per lui, anche dopo anni Grin la notte piangeva di riconoscenza.
La loro è tra le amicizie letterarie più belle della storia. Due scrittori del tutto diversi eppure in grado di riconoscere, apprezzare e incoraggiare ciascuno la grandezza dell’altro. L’uno profeta e campione del realismo socialista, ancorato alla sofferta materialità delle vite più umili; l’altro vagheggiatore di avventurosi riscatti fantastici per mare o in terre immaginarie. La verità è che da qualunque punto parta, quale che sia il suo cammino o la biografia di chi scrive, la letteratura che conta e che resta arriva e si ritrova in gruppo sempre lì: nella piazza grande dei sentimenti umani fondamentali, dove batte il cuore di tutti.
Dal 1924 in poi, in quei suoi ultimi otto anni di vita, Grin visse faccia al mare prima a Feodosija dove nelle mattine d’inverno scriveva nel più assoluto silenzio e d’estate «riposava, vagava lungo il mare, si accompagnava a cani randagi, curava i falchi feriti, leggeva e giocava a biliardo con gli allegri abitanti di quella cittadina in Crimea, discendenti dei genovesi e dei Greci».
Nel 1930 si trasferì a Staryi Krym e lì morì due anni dopo. Morì come in un suo racconto, Il ritorno: «La fine giunse nella luce delle finestre spalancate, al cospetto dei fiori di campo. Già vicino a spirare, egli chiese di sedere presso la finestra. Da lì guardò le colline, aspirando coi bronchi che fiottavano sangue le ultime boccate d’aria». Pochi giorni prima aveva fra le mani le copie d’autore inviategli da Leningrado del suo ultimo libro, Racconto autobiografico: «Sorrise debolmente, cercò di leggere la scritta sulla copertina, ma non poté. Il libro gli cadde di mano».
Nelle poche e mirabili pagine di Vele scarlatte c’è tutto Grin. C’è, per esempio, il padre che avrebbe voluto. Nel romanzo è un marinaio. Si chiama Longren e in avvio subito sappiamo che si congeda «dopo dieci anni di servizio a bordo dell’Orione, un solido brigantino di trecento tonnellate, al quale si era affezionato più di un figlio alla propria madre». Perché lascia, allora? Secondo capoverso, scrive Grin: «Avvenne così». Due parole. Punto. E inizia il racconto, che nel prosieguo sarà favola per un sogno che s’avvera e poema per la filigrana espressiva del linguaggio intessuto di frequenti e rapidi guizzi di pragmatico lirismo. All’inizio, però, Vele scarlatte è tragedia. Una tragedia della fame.
In uno dei suoi rari ritorni a casa, Longren non scorge «come al solito, già da lontano, sua moglie Mary sulla soglia battere le mani e corrergli incontro a perdifiato». Mary è morta. Non voleva né poteva più chiedere credito ai vicini per sé e per quella bambina appena nata con il padre lontano. Cerca, quindi, di impegnare il suo anello nuziale. Lo propone al commerciante più facoltoso del paese ma questi pretende di fare l’amore con lei. Allora Mary decide di provare in città. Si avvia di notte, la sorprende la pioggia. Polmonite doppia. Dopo una settimana muore. Longren lascia il brigantino per amore, solo per amore, per dedicarsi alla piccola Assol. Il suo nuovo lavoro sarà costruire modellini di nave e giocattoli di legno.
Il vecchio e la bambina vivono felici, ricchi del reciproco affetto. Incuranti degli altri, in paese, prima solo lontani, poi anche ostili. Finché un giorno un tipo strano, forse un mago, chissà, fa ad Assol una profezia e da allora ogni giorno lei scruterà il mare sperando che lontano all’orizzonte appaiano… vele scarlatte.
Larga la foglia, stretta la via, continuate voi leggendo che io ho detto la mia.
Aleksandr Grin, Vele scarlatte, Editori riuniti, 2020