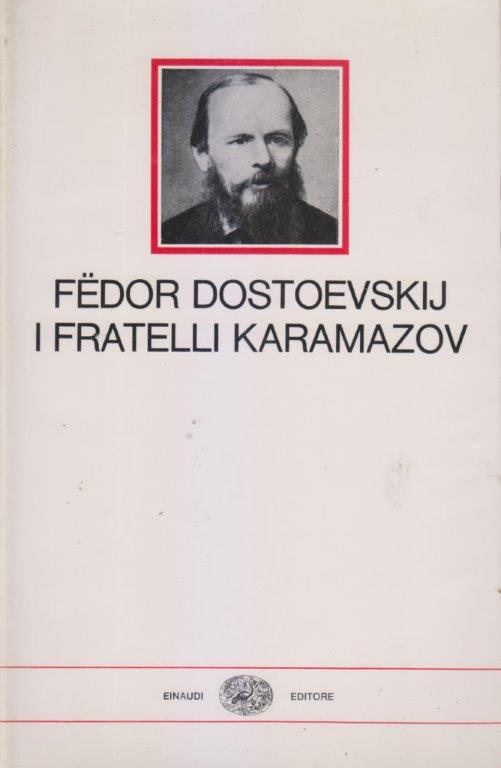
Mostovskoj è in cella di isolamento da tre settimane perché durante una perquisizione hanno trovato nella sua branda dei fogli compromettenti, «gli scarabocchi di Ikonnikov», di cui egli non sa nulla ma che, come vedremo, sono la sua cattiva coscienza.
- Una notte un sottufficiale delle SS lo preleva e lo porta dallo «Sturm-bannführer Liss», l’uomo di Himmler alla direzione del lager. Non sarà né un interrogatorio né una tortura, peggio: una conversazione politico-filosofica durante la quale Liss cercherà di convincere Mostovskoj che «Quando lei ed io ci guardiamo in faccia, non vediamo solo un viso che odiamo. È come se ci guardassimo allo specchio». Liss incalza e Mostovskoj vacilla per il terrore di riconoscersi simile al proprio nemico e come quello strumento del Male.
- Sono venti pagine che potrebbero far corpo a sé, hanno la compiutezza, l’intensità e il ritmo di una pièce drammatica. Leggendole abbiamo pensato alla Leggenda del Grande Inquisitore nei Fratelli Karamazov e, dunque, adesso cercheremo di procedere in partita doppia.
Ivan racconta ad Alioscia il poema fantastico che ha in mente, ambientato nel sedicesimo secolo a Siviglia nel periodo più tremendo dell’Inquisizione. Dopo quindici secoli il Figlio di Dio «come promesso per bocca del Suo profeta… volle manifestarsi almeno per un istante al popolo, al popolo angustiato e sofferente, fetido di peccati, che tuttavia lo amava di un amore infantile».
Accade quel che non era accaduto un tempo: il popolo lo riconosce immediatamente e lo segue osannandolo e chiedendogli miracoli. Subito, però, il Grande Inquisitore, un cardinale novantenne, gli si fa incontro, assiste incupito alla resurrezione di una bambina e poi, con i suoi tetri coadiutori, la sacra guardia, lo porta via. Nel buio profondo di una prigione comincia la requisitoria del Grande Inquisitore.
Analogie e differenze. Il Grande Inquisitore e Liss sono entrambi in una situazione di forza rispetto al Figlio di Dio e a Mostovskoj ma il primo attacca, condanna e sprezza; il secondo è rispettoso e riverente, dice Maestro, rivendica fratellanza e si congeda in modo cordiale.
Il Figlio di Dio è muto, non accenna reazione alcuna, rimane in ascolto fissando l’interlocutore con «sguardo dolce e penetrante evidentemente deciso a non muovergli alcuna obiezione» e quando alla fine l’Inquisitore «vorrebbe che gli dicesse qualcosa, foss’anche qualcosa di crudele, di tremendo egli, all’improvviso, si avvicina al vecchio senza dir nulla e sempre in silenzio bacia le sue labbra esangui, di novantenne. È questa tutta la sua risposta».
Mostovskoj, invece, sbanda fra la durezza di un’esibita opposizione frontale e l’atroce dubbio interiore di una sostanziale condivisione delle argomentazioni dell’altro: «Mostovskoj non aveva paura delle torture. A spaventarlo, piuttosto, era l’idea che quel tedesco non stesse mentendo ma dicesse la verità… Orrore: erano entrambi malati, tormentati dalla stessa malattia…».
Il Figlio di Dio con quell’inatteso e straniante bacio finale cancella distanze. Mostovskoj, invece, alla fine recupera certezze rifiutando ogni richiesta di condivisione ideologica benché da Liss continuamente e convintamente reiterata. I dubbi li ritroverà in agguato negli «scarabocchi di Ikonnikov».
Ma di cosa l’Inquisitore accusa il Figlio di Dio e di cosa, invece, Liss cerca di convincere Mostovskoj? Il primo ripropone le parole del giorno della triplice tentazione nel deserto: «…promettesti agli uomini una libertà che nella loro semplicità e innata sregolatezza non possono neanche comprendere, che incute loro paura e terrore, giacché per l’uomo e per la società umana nulla è mai stato più intollerabile della libertà!». In sostanza l’accusa è di aver affidato agli uomini un compito troppo grande destinandoli così all’infelicità. L’uomo è costituzionalmente incapace di sostenere il peso della libertà.
Rifiutando di trasformare le pietre in pane, l’esercizio del potere temporale su tutti i regni della terra e, infine, di buttarsi nel vuoto dalla cima del tempio: il Figlio di Dio rifiutò il miracolo, il mistero e l’autorità affinché gli esseri umani lo amassero per consapevole e libera scelta e non perché asserviti a un potere superiore, ma così – lo accusa l’Inquisitore – «invece di impossessarti della libertà umana, l’hai moltiplicata, aggravando in eterno coi tormenti della libertà il regno spirituale dell’uomo».
Egli, quindi, rivendica la necessità di dominare gli uomini per dare sollievo alla debolezza strutturale dei più, rendendo vivibile la loro condizione votata alla sofferenza. Vite altrimenti misere, soggiogate, acquistano senso. Ingannare gli uomini è amore, puro e tormentato: «Non abbiamo forse amato l’umanità, riconoscendo con tanta umiltà la sua impotenza, alleggerendo con amore il suo fardello, permettendo addirittura anche il peccato alla sua debole natura, ma con il nostro permesso? … bisogna accettare la menzogna e l’inganno, condurre ormai del tutto consapevolmente gli uomini alla morte e alla distruzione, per di più ingannandoli lungo tutto il cammino affinché non vedano dove vengono condotti e almeno per strada questi miseri ciechi credano di essere felici».
Diverso è il modo di porsi dei due carcerieri ma uguale è il senso delle loro affermazioni. Cambia la forma, non altro. Entrambi rivendicano di essersi fatti carico dell’irrimediabile incapacità umana di meritare e vivere la libertà: gli uni nascondendo il volto feroce del dominio in un’istituzione subdola e remissiva, ma non per questo meno feroce, gli altri ostentando la propria volontà di potenza, convinti, gli uni e gli altri, di essere depositari di una verità e una forza negata ai più e da loro quindi esercitata con spietatezza ma amorevole tormento nell’interesse collettivo, sia esso l’umanità, la razza, la patria o partito.
Per quanto si dimeni cercando di divincolarsi, al di là della resipiscenza e dello scarto finale, Mostovskoj è preso al laccio dalle labirintiche circonvoluzioni di Liss: «Attacchiamo voi, ma in realtà colpiamo noi stessi… È terribile, è come sognare il suicidio… E se dovessimo vincere… Voi non ci sarete più, e noi, i vincitori, ci ritroveremo soli contro un mondo che non conosciamo e ci odia… Ma se noi vinciamo, vincete anche voi. Mi capisce? E se anche vinceste voi, noi saremmo spacciati, sì, ma continueremmo a vivere nella vostra vittoria. È una sorta di paradosso: se perdiamo la guerra, la vinciamo e ci sviluppiamo in un’altra forma pur conservando la nostra natura».
Perché, di fatto: «Siamo due ipostasi della stessa sostanza: uno Stato partito… Come potete non riconoscervi in noi, non vedete in noi la vostra stessa volontà? Il mondo non è forse pura volontà anche per voi?». Allargando il perimetro con la chiamata di correo ai totalitarismi, Grossman attualizza la requisitoria di Dostoevskij contro l’esercizio abusivo del potere. Per nessuno dei due è un giudizio morale o una condanna ma un’analisi e una denuncia.
parte seconda – continua
Fëdor Dostoevskij, I fratelli Karamazov, Einaudi, pagg. 1064
Vasilij Grossman, Stalingrado, Adelphi, pagg. 884
Vasilij Grossman, Vita e destino, Adelphi, pagg. 982

