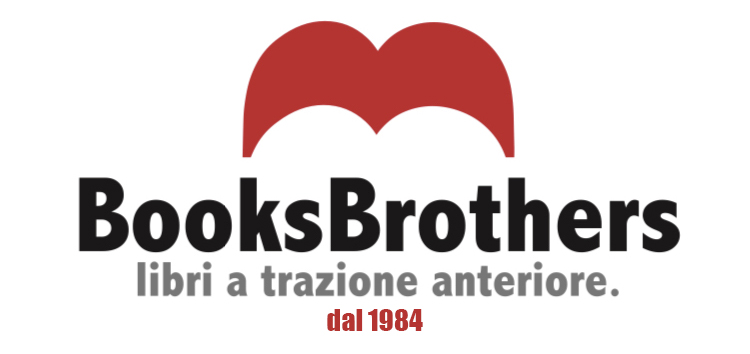Ma c’è una parola per dire tutt’insieme incredulità-disappunto-sconcerto-rabbia-frustrazione-scoramento e congetture imbizzarrite di pensieri e ipotesi in lotta fra loro? Non lo so, non la conosco perciò mi limito a riferire i fatti, con passo tardo e lento e animo dolente di ferita aperta e sanguinante.
Per questo Faccia a faccia con Sebastiano Vassalli ho tirato giù i suoi libri. Erano nella scaffale più alto. Ho dovuto prendere la scaletta. Li ho messi sulla scrivania, alla rinfusa. Tre pilette di 14 cm. In totale ventisette. Tutti, o quasi, i suoi titoli, mi dico compiaciuto. Forse, penso, mancano gli ultimissimi, quelli usciti dopo il 2007, nel periodo del mio lavoro in libreria quando ho allentato l’impegno critico e i libri che mi interessavano li portavo a casa in commodato d’uso gratuito. Una lettura e via.
C’è il blocco degli Einaudi, quello portante, prime edizioni e tascabili, leggo in ordine di apparizione i titoli sul dorso della piletta di sinistra, che ho sotto gli occhi. A far da base, formato extralarge, Le parole degli anni Ottanta (Zanichelli), un vocabolario del Neoitaliano di quattrocento parole, di ognuna delle quali è ricostruita la storia con divertente e affettuosa ironia sui «banali – e perciò benedetti – anni Ottanta» …
… ai piani superiori, La chimera, premio Strega 1990, Il cigno, la mafia, L’oro del mondo, il fascismo e l’antifascismo last minute, Cuore di pietra, la storia d’Italia nelle mura di una casa, 3012, una lente distopica sul presente… e via via, a seguire, i Baldini&Castoldi degli anni dell’esilio da Einaudi, fra cui La notte del lupo e Gli italiano sono gli altri, sul nostro carattere nazionale …
… poi, nella piletta perpendicolare alle altre due, le ristampe dei lavori avanguardistici dei primi anni, Mareblù (Mondadori), e Abitare il vento (Calypso), i tascabili Einaudi, L’alcova elettrica, una ricostruzione del processo del 1913 ai futuristi fiorentini di Lacerba per offese al pudore, Sangue e suolo, sulle discriminazioni patite dagli italiani in Alto Adige, Dux, basta la parola, e le Belle lettere (con Attilio Lolini) ad amici ed editori (A Giulio Einaudi, 6 dicembre 1987: «Te l’avevo mai detto che sono un venditore ambulante? Mi iscrissi alla camera di commercio sei anni fa, prima di venire ad abitare qui a Pisnengo… Ho la licenza… Non ne feci niente perché poi Giulio Bollati mi incoraggiò a fare lo scrittore»), quindi i preziosissimi Interlinea Natale a Marradi, Dino Campana again, Il robot di Natale …
… infine, imperdibile, Maestri e no, perlopiù prefazioni a edizioni scolastiche, dodici incontri tra vita e letteratura, che definiscono la postura verticale di un intellettuale che dalla sua altezza ha messo in scala protagonisti ed epigoni del nostro tempo e non solo, a cominciare dall’apostolo Paolo, oggetto di un’aspra polemica con l’Einaudi e altri (anche Luciano Canfora) per questo punto di vista osteggiato e censurato (con subliminale accusa di antisemitismo) in una prefazione del ’99 a una Lettera ai Romani: «La chiave di volta della religione cristiana… è nel rapporto tra Gesù e Paolo, tra il distruttore di religioni e il costruttore di religioni… Gesù da solo (lo dico con qualche rimpianto) non poteva bastare… La sua personalità è grandiosa e poetica… ma inconcludente sul piano delle cose concrete» …
- … a seguire Gustave Flaubert («Bouvard e Pécuchet sono i simboli e gli eroi dell’Occidente, nel momento in cui l’Occidente raggiunge il massimo della sua potenza e della considerazione di sé. Rappresentano un secolo, l’Ottocento… ma si potrebbero trasferire anche nella letteratura e nella realtà dei secoli successivi»), Giovanni Faldella («… le sue Figurine sono un piccolo capolavoro della letteratura dell’Ottocento»), Ernesto Ragazzoni («Fu, in nome della poesia, uno straordinario dissipatore del suo talento e della sua stessa vita. Questo me lo rende caro»), Dino Campana, Antonio Gramsci («… non era un uomo di legno come Togliatti, capace di galleggiare dappertutto… Più che un grande comunista e un grande politico, io lo considero un grande italiano»), Dino Garrone («La discarica universale delle storie è il nuovo orizzonte della letteratura, nel presente, e Dino Garrone: il profeta del silenzio e del nulla, rappresenta il passato… Meglio quel passato o questo presente? Chissà»), Louise-Ferdinand Céline («… Louis Destouches non era un uomo malvagio. Al contrario: nella vita di ogni giorno era un uomo buono… Non era un intellettuale, però. Era un artista, e il suo temperamento lo esponeva al rischio di assorbire gli umori dell’epoca e di diventarne, in qualche modo, l’interprete»), Renata Viganò («L’Agnese va a morire è una delle opere letterarie più limpide e convincenti che siano uscite dall’esperienza storica e umana della Resistenza»), Danilo Dolci («… uno scrittore che ha voluto andare tanto vicino al vero da rinunciare, in pratica, ad essere uno scrittore in prima persona»), Malcom X («Era un Gramsci nero e americano»), infine Lorenzo Milani («La Lettera a una professoressa è una patacca. La più grande patacca del secolo»).
L’opera di Vassalli sconfina dai romanzi e dalla letteratura. Ognuno a modo suo, ma di voci dissonanti, ad ampio spettro e forza d’urto civile, dopo Pasolini, cronologicamente, c’è Vassalli. Poi, non so …
… l’altra piletta è coperta e da qui non leggo i titoli ma sono tutti gli altri Einaudi. Vedo solo di piatto la copertina di quello più in alto, L’Italiano, ma «Chi, io?», dice nella prima pagina l’Italiano chiamato in causa al Giudizio universale, poi nelle ultimissime pagine affaccio panoramico su Arcore e profilo dell’Arcitaliano, che ha incarnato il peggio del nostro carattere nazionale, ancorché simpaticamente, e ha tradito il progetto patriottico di Bettino Craxi, «… giocava con la maglia del Partito Socialista italiano; in realtà, era un nazionalista… Bisognava finire ciò che era stato incominciato da Garibaldi. Bisognava innanzitutto che i nostri soldi: quelli del Paese Legale ma anche quelli del Paese Sommerso, anziché andare all’estero restassero in Italia, per creare lavoro e benessere… Fu così che Craxi creò l’Arcitaliano», che sarebbe dovuto essere l’antidoto ai vari Sindona, Calvi, Marcinkus. E invece…
Guardo le tre pilette sulla scrivania, sembrano una fortezza. Libro su libro, pietra su pietra, passo editoriale da maratoneta. La scrittura è un demone ma, oltre a velocità, versatilità e orizzonte mobile dello sguardo, servono anche ordine e meticolosità. Al di là del fuoco che brucia dentro, e del talento che lo alimenta, scrivere storie è un lavoro artigianale e dispotico che richiede costanza e disciplina di studio e documentazione, e anche paziente e funzionale archiviazione. Vassalli era così, nella laboriosa solitudine del suo faccia a faccia con la Storia e le storie.
- Era come dice nella prima poesia del lavoro tra i suoi a me più caro, Il finito, con cinque disegni di Michelangelo Pistoletto, Edizioni El Bagatt, Bergamo, agosto 1984, proprietà letteraria dell’Autore, edizione fuori commercio, omaggio dell’autore. Tre sezioni: Il finito (traduzioni), L’infinito (frammenti), La poesia (prose). Me lo regalò, nell’autunno di quel 1984, alla fine dell’intervista per La notte della cometa. Nella parte interna del retrocopertina di suo pugno indirizzo e telefono: 28060 PISNENGO di CASALVOLONE (NO) tel. 0161 – 315318.
IL FINITO (da G. Leopardi), a M. Pistoletto Sempre odioso mi fu quest'affollato mio tempo, e questo schermo, che i fantasmi degli umani e le voci in sé racchiude. Ma ovunque io mi nasconda, il turbinio di vanamente fragorose imprese m'insegue e mi raggiunge, né potrei sottrarmi ad un destino che accomuna me coi viventi. - E come invece è eterno e in sé perfetto un sasso, a volte io quello mi fingo d'esser nel pensiero, e in lui finisco; e mi dimentico l'effimero, e le vive stagioni, e quella morta e assente, e il suo silenzio. Così annullo l'ansia del tempo nella carne e il vuoto della ragione riempio e chiudo e sono.
- Ho citato titoli alla rinfusa, cedendo alla pigrizia. Mi assolvo dicendomi che in docile scansione cronologica sono già in rete. È allora che succede… Penso: cominciamo dall’inizio, perciò cerco La notte della cometa, il romanzo della vita vera di Dino Campana, al di là di ogni distorsione e leggenda, pietra angolare che del percorso letterario di Vassalli segna un prima e un dopo. Lo cerco, lo cerco quel libro con all’interno una lettera di saluto dell’autore dopo la pubblicazione dell’intervista, una bella sorpresa in un momento personale non certo brillante. Lo cerco, quel libro, lo cerco tra gli altri… e non lo trovo. Mentre continuo stupidamente a scorrere i titoli di costa delle pilette, mi si slarga un vuoto dentro e avanza la certezza che di questo libro io ho perso le tracce da tempo, forse addirittura dal primo trasloco dal Nord. Infine, mi arrendo e come Herbert[1] alla penna, all’inchiostro e alla lampada della sua infanzia, chiedo anch’io perdono a me stesso per la «grande e imperdonabile infedeltà» che mi ha fatto dimenticare La notte della cometa smarrendolo chissà dove senza minimamente rendermene conto.
Chiudo gli occhi e ripenso a quella prima volta a Pisnengo di Casalvolone. Ci andai in machina, come arrivarci altrimenti? La macchina era una coupé d’un certo pregio, anni prima, ma ormai fuori produzione, un po’ vintage, diciamo così. A scuola le ragazze, Cristina e Alessandra, mi prendevano in giro e la chiamavano catorcio, io ribattevo, macché… bolide. Fatto sta che a Pisnengo ci arrivai, con comodo e senza impicci di motore.
Di quel paesino sperduto nella nebbia della campagna piemontese Vassalli diceva: «Oggi c’è troppo frastuono e la parola è la cosa più inflazionata. Chiunque voglia scrivere seriamente ha bisogno di un posto come questo. E deve trovarlo: anche nel cuore di Parigi». Il suo posto era una canonica abbandonata con un orto cui dedicava molta cura, un camino e tanti quadretti alle pareti, colorati e naïf come degli ex voto con tutti i personaggi più in vista della storia italiana recente: da Scalfari, a Curcio, ad Arbasino… Sebastiano Vassalli ringraziava così il suo dio per essere sfuggito alle grinfie del conformismo politico e culturale e a quel suo passato remoto che l’aveva visto condividere gli atteggiamenti delle avanguardie, prima del tempo molto solitario e operoso a Pisnengo, frazione di Casalvolone.
«They were all torn / and covered with / the boy’s blood». Con questa epigrafe – «le uniche parole veramente importanti del libro», come egli stesso ebbe a scrivere nella lettera testamento del 1916 a Emilio Cecchi – chiuse i suoi Canti orfici Dino Campana, il folle di Marradi morto in un manicomio nel 1932 dopo quattordici anni di internamento. «Essi erano tutti stracciati e ricoperti del sangue del fanciullo.»
Questi versi racchiudono in mirabile sintesi poetica il significato complessivo di una vita consapevolmente vissuta come sacrificio, ma sono anche un terribile atto d’accusa contro le ragioni di chi quel sacrificio impose e di chi poi a lungo lo ha ignorato o sminuito invitando a stendere su di esso un velo di pietà (come nel saggio introduttivo all’edizione dei Canti, Oscar Mondadori, marzo 1972) oppure a inscriverlo nel generico e rassicurante orizzonte di una normale devianza che la società del tempo non sapeva curare se non con la reclusione in manicomio (Paolo Mauri, Repubblica, 3 gennaio 1985).
Chissà, forse sono stati proprio questi versi sul «sangue del fanciullo» a spingere Vassalli a una ricerca di quattordici anni per raccontare in un romanzo («componimento misto di storia e invenzione», come lo concepiva Manzoni) la vita del suo «babbo matto». La notte della cometa è una ricostruzione fedele e avvincente condotta con «accanimento, scrupolo e spirito di verità» e, dunque, con rigore documentario e filologico ma, soprattutto, con quell’intuito e passione di poeta indispensabili per fare chiarezza sui troppi e troppo marchiani luoghi comuni che a lungo hanno gravato sulla vita di Campana.
Nella quiete della canonica abbandonata, in quel lontano sabato pomeriggio la nostra conversazione andò più o meno così.
Il capitolo più doloroso: Campana pazzo.
Secondo la famiglia, tanto la madre quanto il padre, secondo i marradesi e il segretario comunale in particolare, tale Buvicini Capecchi, secondo le avanguardie fiorentine del tempo, Soffici – suo cugino – e Papini, soprattutto: insomma, secondo la leggenda, Dino Campana pazzo lo è sin dall’adolescenza per ragioni ereditarie, tanto pazzo da non godere mai dei diritti politici, tanto pazzo che gli scrissero sul passaporto «può girare solo se accompagnato dal tutore», tanto pazzo che – come a un pazzo si conviene – morì in manicomio.
Ebbene questo «matto per vocazione» matto non lo fu davvero se non a partire dal 1916 quando le sue cellule nervose furono devastate dagli sviluppi di un’infezione luetica. Dunque matto, come matto fu Nietzsche, come matto è un malato di sifilide nello stadio terminale della malattia e matto solo dal 1916: oltre i trent’anni e quando i Canti orfici erano già stati pubblicati da due anni. Con la follia si spense la vena poetica: «O poesia tu più non tornerai / Eleganza eleganza / Arco teso della bellezza / La carne è stanca s’annebbia il cervello si stanca… ».
Perché allora tutti Dino Campana l’hanno creduto e voluto matto prima ancora e indipendentemente dal fatto che lo fosse davvero? La domanda aveva l’urgenza di una protesta contro un’ingiustizia intollerabile.
«Non è domanda da poco – rispose Vassalli con quieta forza argomentativa – perché pone in questione il rapporto tutto tra Campana e il suo tempo. La realtà è che c’è all’origine un contrasto di fondo fra Campana e il suo tempo che io arrivo ad individuare in questo: Campana pretende di essere poeta – e sottolineo la parola essere – in un’epoca in cui chiunque può fare il poeta ma nessuno propriamente lo è. All’origine di tutto io credo ci sia proprio un contrasto emblematico tra la cultura del tempo (non solo le avanguardie artistico-letterarie ma tutto l’universo culturale e ideologico che le produce) e questo suo modo apparentemente ingenuo, primitivo, barbaro, naïf di concepire l’arte. Questo contrasto diventa clamoroso (e tragicomico: con Campana che vuole accoltellare Papini) quando si accosta a quelli che fanno i letterati di professione e che sono attrezzati per farlo con le loro riviste, i loro caffè, i loro circoli. Campana finisce per essere alternativo a questi, che sono più propriamente filosofi, secondo la distinzione di Leopardi, a questo loro modo di intendere la poesia come tecnica cerebrale, per cui essi devono negare Campana, e lo faranno anche dopo la sua morte, perché se lui esiste non esistono loro.»
Fu, dunque, dapprima l’estraneità all’angusto e conformista orizzonte culturale della propria famiglia e del proprio paese a fare di Dino Campana un diverso e, quindi, un folle; mentre la follia dell’uomo divenne, poi, nelle mani dei Soffici e dei Papini, una terribile arma per screditare il poeta che consapevolmente si opponeva al loro modo di intendere l’arte. Poesia pura da una parte, tecnica cerebrale dall’altra: è l’antica distinzione leopardiana tra poesia e filosofia (o moderna eloquenza) quella che Campana ripropone con il sacrificio della sua persona.
È un’idea d’arte ardua e aristocratica («Tutto è sforzo individuale») quella che Campana va maturando già ventenne e che lo spingerà a considerare i letterati del suo tempo «dilettanti senza solide basi e senza serie aspirazioni», ad accusarli di dilapidare la tradizione artistica italiana e di essere soltanto dei parvenu, dei ladruncoli.
Inverno 1913. Campana arriva a Firenze, a piedi come suo solito, senza soldi in tasca, vestito di stracci («i pii piedi diguazzanti in un paio di scarpe sdotte e scalcagnate, mentre intorno alle sue gambe ercoline sventolavano i gambuli di certi pantaloni troppo corti per lui e d’un tessuto incredibilmente leggero, giallastro, a fiorellini azzurri e rosei… ») con l’unica speranza riposta nel sacco di iuta che l’accompagna con dentro il manoscritto dei Canti («Ho bisogno d’essere stampato: per provarmi che esisto, per scrivere ancora ho bisogno d’essere stampato»). In quell’inverno del 1913 i futuristi a Firenze si atteggiano, si gerarchizzano, si preparano all’appuntamento con la gloria. Sono il volgo letterato dei minorenni che giocano alla letteratura («Carrà interviene: Ehi, lei. Uomo dei boschi. Ce l’ha una pelle di capra? Dino lo guarda sbalordito e lui si rivolge a Soffici, gli dice: Se ci promette di venire a teatro vestito solo d’una pelle di capra, noialtri gli procuriamo un biglietto hommage, non è vero Soffici?»): ma Dino dorme all’asilo notturno, non ha tempo né voglia di giocare. Infreddolito e affamato ritorna a Marradi dove riuscirà a pubblicare i canti presso il tipografo Ravagli (estate del 1914).
Rifiuto della tradizione, «frasaismo borghese», «macchiavellismo» da una parte e continuità dall’altra con «la poesia italiana che fu o toscana». Sono anche questi i termini dello scontro che costò a Campana la pazzia: prezzo troppo alto per un uomo e a esso, infatti, Campana tentò di sottrarsi offrendosi volontario allo scoppio della guerra per essere reintegrato nei suoi diritti di cittadino. Ma era ormai troppo tardi.
«Ecco perché – tirò le somme Vassalli, ravvivando la brace nel camino – l’offesa più grave al poeta è stata quella di avercene consegnato l’immagine come di un epigono attardato e paesano dei poeti maudit francesi, un Rimbaud di periferia. Nulla ha a che vedere Campana con Rimbaud, nemmeno i viaggi che dovette fare per forza. Campana intendeva, invece, ricollegarsi a un’idea di classicità che in qualche modo esemplificava in Carducci. Potrei dire, e chiedo scusa per il paragone che spaventa anche me e che vorrei venisse preso con tutte le debite proporzioni, potrei dire che Campana è stato un po’ il mio Virgilio. Attraverso Campana è maturata la mia liberazione dalle teorie letterarie, dalle pratiche delle avanguardie delle quali ho fatto anche parte. Teorie letterarie e pratiche che sono poi le stesse, in altro modo e in altri tempi, di quelle contro cui Campana, al contrario della mia generazione, era venuto in contrasto».
Infine.
«Io individuo una linea di continuità che da Lacerba arriva fino ad Alfabeta, tra l’altro si somigliano anche graficamente. Teorie letterarie e pratiche, contraddistinte dal primato della riflessione sull’arte, che considero nocive, che hanno isterilito la mia generazione. Del resto le avanguardie letterarie italiane non hanno mai prodotto opere artistiche di rilievo ma solo gruppi di potere, ideologia. Campana è l’ultimo poeta italiano, l’unico che varcherà le soglie del secolo nonostante la critica lo tenga ancora in un angolino, nonostante manchi ancora un’edizione critica della sua opera. Il lungo studio e il grande amore che fece cercare a Dante il volume di Virgilio nacque dalla stanchezza, dal dispetto per i suoi contemporanei dello stil novo. In fondo, fatte tutte le debite proporzioni, credo che il processo sia lo stesso.»
[1] Zbigniew Herbert, Elegia per l’addio della penna dell’inchiostro della lampada, Edizioni di Vanni Scheiwiller, Milano 1989
https://www.ilmondonuovo.club/sebastiano-vassalli-un-babbo-matto/