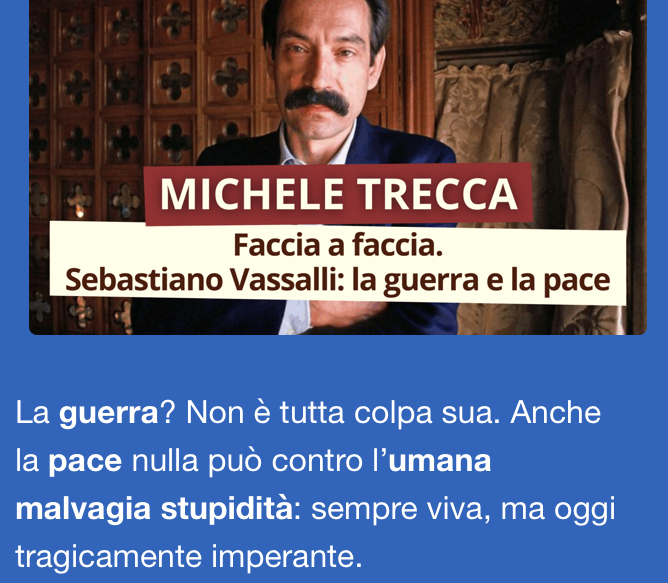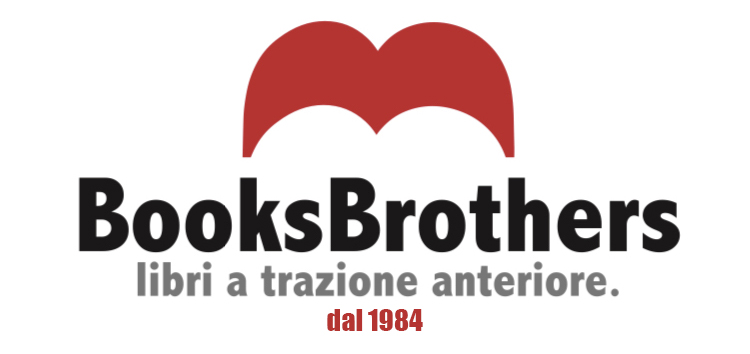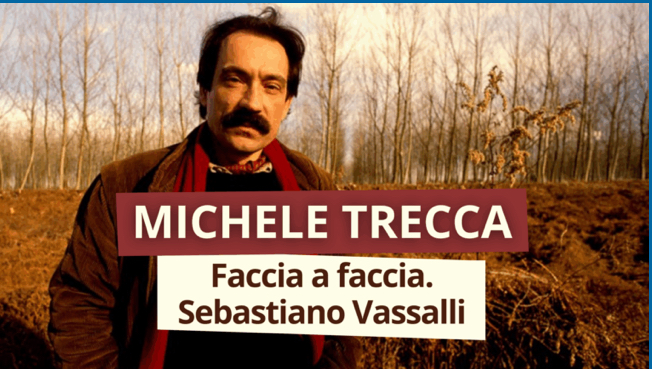
L’onestà intellettuale è un prerequisito della grande letteratura. Ne sono convinto. Il talento, insieme a tante altre cose, è decisivo, ma secondario. L’onestà intellettuale di cui parlo non ha a che fare con la morale, è limpidezza di sguardo. Sulle cose del mondo e della vita. È terreno fertile per il talento, che altrove non attecchisce. La creatività è invenzione, non menzogna. I romanzi che contano sono tutti veri non perché ciò che raccontano corrisponde alla realtà, ma per quel tessuto connettivo in inchiostro simpatico dov’è fra le righe la visione (tu chiamala Weltanschauung oppure, se vuoi, impronta letteraria) che l’autore, consapevole o meno, forma e scopre dentro di sé scrivendo e rimpastando nella scrittura se stesso e la propria cultura.
In ogni narrazione c’è «uno spazio vuoto di percezioni fisiche… la forma plastica di un’ombra», da Combine Art sulle DelocAzioni di Claudio Parmigiani. In ogni intervista le parole di Vassalli hanno sempre messo in chiaro quell’ombra. Come in questo caso.
- L’oro del mondo è romanzo di stupefacente freschezza e attualità, che unisce accenti classici dickensiani alla sferzante denuncia del male atavico del trasformismo. È il racconto di un’adolescenza disastrata e avventurosa, al tempo stesso sofferta e felice. Sparito il padre all’inseguimento di vedove, «l’infame»; abbandonato dalla madre che accudisce un capitano di vascello invalido per puntiglio più che per il miraggio di un’eredità: il piccolo Sebastiano cresce con lo zio Alvaro, reduce di guerra, scampato miracolosamente a una fucilazione a Cefalonia.
Tenero e sprovveduto, sempre stupito dalla proterva e feroce insensatezza del mondo, il piccolo Sebastiano è in lotta continua per la sopravvivenza nel sottobosco padano degli emarginati vari in cerca di fortuna del secondo dopoguerra. Lo zio Alvaro, per esempio, si spacca la schiena setacciando le rive dei fiumi lombardi per rimediare qualche granello d’oro. In cima all’orizzonte del romanzo: il re in fuga, svampito e deriso; i generali vincitori, feroci e sfrontati; il duce e la consorte, ridotti dalla sconfitta a patetiche caricature. Insomma, più miserabili e meschini i potenti degli umili che si arrabattano nei bassifondi. Né migliori sono le avanguardie letterarie a gettone che sbafano le giornate fra una presentazione, un’introduzione e un coccodrillo. Sebastiano, ormai adulto e aspirante romanziere, pur condividendone la fame, non riuscirà e non vorrà intrupparsi con loro.
«L’oro del mondo – cominciò Vassalli in quel nostro secondo incontro nella quiete della ex canonica di Pisnengo – è il tentativo di appiccicare un’ombra a chi non ce l’ha, di porre uno specchio davanti a qualcuno che non vuole vedere la sua immagine. Il punto vero del libro è costituito dalla rimozione operata dalla cultura italiana di mezzo secolo della nostra storia e cioè i primi cinquant’anni del Novecento. Un esempio per tutti: Se questo è un uomo di Primo Levi nel ’47 fu rifiutato da Einaudi (e pubblicato dall’autore a sue spese come, del resto, è avvenuto per tutta la memorialistica di guerra) ma non perché Giulio Einaudi o Natalia Ginzburg (che lo lesse allora) fossero dei cattivi: il fatto è che chi vive dentro una nevrosi è necessariamente nevrotico. Nessuno può sollevarsi per i propri capelli. Ora hanno fatto la commissione d’inchiesta su Leopoli: ma di Leopoli ce ne sono state tante e si sa tutto perché ne parlano le cronache dei giornale dell’epoca. Basterebbe leggerle, ma nessuno lo fa perché quella rimozione è ancora viva.»
I primi cinquant’anni del nostro Novecento sono stati una stagione crudele, come ogni processo di crescita. «Marzo e Aprile – continuò Vassalli, citando Eliot – sono i mesi più crudeli dell’anno: lo sono comunque. Io sono un ammiratore della cultura tedesca perché è una cultura adulta che è arrivata a chiedersi quale rapporto ci sia tra Goethe e Auschwitz. La nostra, invece, non solo non si conosce ma non ha nemmeno avuto il coraggio di guardarsi.»
Una stagione, quindi, che non è lecito cancellare solo per nascondere quel peccato collettivo che fu il fascismo. Vassalli non si è nascosto: «Come la maggior parte degli italiani, i quali però dichiarano la loro origine sono quando hanno i quattro quarti di nobiltà resistenziale, anch’io ho avuto un padre fascista. E ciò mi accomuna al protagonista del romanzo. Per il resto le due figure non coincidono. Ma gli ho voluto dare ugualmente il mio nome per guardare anche la pagliuzza nel mio occhio mentre guardavo la trave in quello degli altri».
Pisnengo non era una torre d’avorio ma una finestra aperta sul mondo. Al di là della quale c’era qualcuno che non aveva paura di dire pane al pane e vino al vino. Con onestà intellettuale. Sempre. Anche e soprattutto quando per le misteriose e avventurose vie della letteratura si è imbattuto in peccati grossi come macigni che da sempre opprimono la nostra coscienza e dei quali forse non ci libereremo mai. Perciò preferiamo dimenticare. Anzi, dobbiamo: è legge di natura.
- Abbiamo dimenticato le streghe e l’Inquisizione. Abbiamo dimenticato la Controriforma e la dominazione spagnola. Abbiamo dimenticato i matti e i manicomi. Sebastiano Vassalli, invece, ha «abitato» per anni con lucida follia prima nel Seicento insieme ad Antonia, la strega di Zardino mandata al rogo a vent’anni, poi con Mattio Lovat, autoproclamatosi messia all’inizio dell’Ottocento e rinchiuso fino alla morte nell’isolotto di San Servolo a Venezia. Le loro storie sono tra le pagine più intense della sua opera letteraria.
La chimera è un libro destinato a durare, lo pensai subito, appena letto, e prima ancora di scriverlo nell’intervista lo dissi a Vassalli, che nei suoi occhi profondi aveva orizzonti diversi da quelli effimeri del successo. Nel suo volto scarno scandito dai baffi folti, nei suoi modi, orgogliosi e schivi, apparentemente distaccati e burberi, c’erano consapevolezza, passione e pudore. Quasi lo rivedo mentre con l’attizzatoio ravviva il fuoco nel camino e con quieto disincanto dice: «Non vale la pena raccontare storie così. Solo un matto può farlo. Non c’è proporzione tra l’impegno e i risultati. Ogni libro vive solo una stagione, vince il suo bravo premio, in Italia un premio non si nega a nessuno, e poi tutto finisce».
- Il nostro incontro fu a gennaio, a ridosso dell’uscita del romanzo. Immagino sapesse già della candidatura allo Strega, poi vinto. Quella sera di luglio del 1990 ero Roma nel Ninfeo di Villa Giulia, come un tranquillo e beneducato tifoso sugli spalti dello stadio. Di sfuggita colsi questo acido commento di un giornalista mondano: Adesso può stare tranquillo, non è più una chimera. Sorrisi, ripensando alla nostra conversazione di qualche mese prima. Questa.
«È stato un viaggio lungo e faticoso ma straordinario. Mai – cominciò Vassalli – i morti furono vivi come in quell’inizio di secolo: se fosse possibile raccontare il presente, se qualche contemporaneo avesse potuto raccontare quella sua epoca, noi oggi avremmo la più grande letteratura di tutti i tempi.»
– Ma come è arrivato Sebastiano Vassalli nel Seicento?
«In realtà io ho fatto come Cristoforo Colombo: cercavo le Indie ed ho trovato l’America ma, invecchiando, mi sono accorto che succede sempre così per queste nostre avventure di carta, almeno quando la determinazione del viaggio è seria.»
La fiamma era alta nel camino dell’antica canonica di Pisnengo, a due passi dalla Sesia e dai luoghi della storia. Altrettanto alto era il mio interesse a rivivere con il loro babbo matto i tanti personaggi del libro: il vescovo Bascapé («il Bucharin della Controriforma, l’ala perdente, l’estremista che voleva che tutti i cristiani fossero santi; io non sono un credente ma in qualche modo gli assomiglio»), il parroco Don Teresio («oggi sarebbe un politicante»), il bandito Caccetta («ho il fondato sospetto che Manzoni si sia ispirato a lui: sia per Don Rodrigo che per l’Innominato») e poi Antonia, la protagonista, al rogo giovanissima per l’eresia della sua bellezza e vivacità («ma la sua storia è solo una linea mediana tra tante altre, più grandi e meno grandi; solo un rivolo di infelicità privata»).
«Nel mio precedente romanzo, L’oro del mondo – continuò Vassalli – io avevo cercato di acchiappare il carattere nazionale del nostro popolo negli anni dal ’43 al ’45: nella migrazione, cioè, dal fascismo alla democrazia, in quella sorta di ora legale o volo delle quaglie degli italiani. Mi sono accorto, però, che il fascismo non è, come dicono gli storici, beati loro!, solo un momento della nostra vicenda nazionale. Mi sono accorto che esso riflette molti connotati profondi del nostro modo di essere e di vivere e che, quindi, le radici della mala pianta (o carattere nazionale) andavano cercate ancora più lontano. Ho trovato così il Seicento.»
La chimera è romanzo che commuta in oro narrativo una documentazione storica possente, e avvincente nei suoi incredibili e minuziosi risvolti almeno quanto le drammatiche vicende dei vari personaggi.
– Perché proprio il Seicento?
«Perché l’Italia moderna – sostenne Vassalli – nasce proprio dall’intreccio tra Controriforma e dominazione spagnola. Lì sono i nostri tratti unitari. La Controriforma, anche se non ci piace, è l’unica rivoluzione o controrivoluzione che ha avuto il nostro Paese. La stessa Resistenza, come dicevo, ha riguardato poche persone e poche regioni. La Controriforma, invece, fu un fatto grave, enorme, sanguinoso, che incise in profondità toccando veramente il modo di essere e di comportarsi della gente di tutti i livelli sociali. E il Cristianesimo, che si stava affievolendo, fu reimposto nelle campagne con il terrore della morte.»
– Cosa dobbiamo, invece, agli spagnoli?
«Intanto c’è da dire che anche la dominazione spagnola toccò un po’ a tutti, dal Nord al Sud. Gli spagnoli imposero certi modelli comportamentali che allora non appartenevano alla nostra cultura come la necessità di essere furbi ad ogni costo, di doversi sopraffare gli uni con gli altri. Gli spagnoli erano quelli che, per quanto duchi o principi, mandavano i loro figli nei bassifondi perché diventassero dritti, si facessero le ossa.»
– Il Seicento è il secolo dei Promessi sposi. Quali le differenze di interpretazione di quel tempo?
«Il mio Seicento è molto più vicino a quello della Colonna infame che non a quello dei Promessi sposi. Senza voler minimamente discutere la grandezza del Manzoni, sta di fatto che il suo Seicento doveva far da sfondo al Risorgimento. È un Seicento in positivo, più connotato dall’ottimismo dell’intelligenza. E non è neppure, come hanno già detto diversi storici, un Seicento del tutto credibile: un delinquente come Don Rodrigo, per esempio, non si sarebbe certo preoccupato che la donna da lui desiderata fosse sposata o meno.»
– Ma cosa contava una donna nel Seicento?
«Nulla. Poteva avere una sua grandezza letteraria come santa o peccatrice, ma come persona non contava nulla. E questo si riflette anche in Lucia, piuttosto scialba nonostante la grandezza di Manzoni. Fu allora, infatti, che prevalse l’anima maschilista del nostro popolo. Perciò io ho scelto come protagonista una donna: il Seicento, come io lo immagino, poteva rivivere solo cogliendolo dalla parte in ombra della Luna.»
– La Luna poi ha illuminato le chimere degli uomini…
«Ecco, ecco: quelle sono le Americhe che ho trovato andando verso le Indie. Un tempo si diceva, nel primo Ottocento, che le illusioni (io le chiamo chimere) fossero necessarie alla vita. E oggi, a dispetto di quanti hanno creduto di fare l’arte moderna o contemporanea, noi siamo ancora lì: a Foscolo, a Leopardi. Forse, però, questi duecento anni ci sono serviti a capire che le chimere aiutano a vivere ma non sono animali miti e benefici. Sono animali carnivori. In questi nostri giorni, in questo nulla, in questo presente noi stiamo vedendo crollare il marxismo, una piccola chimera legata alla paura dei bisogni materiali. Il mio libro, in definitiva, ha sullo sfondo la più grande in assoluto delle chimere: quella che forse non morirà mai perché è legata alla paura della morte. È anch’essa un animale carnivoro: ci aiuta a vivere ma si nutre di noi. Per quanto, forse, nel nostro presente, qui in Italia, non morde più.»
– Ma qual è la personale chimera di Sebastiano Vassalli?
«La mia chimera! La mia chimera è che la letteratura, l’invenzione possano ridarci qualche frammento di realtà perché la storia, per me, non esiste. È solo un nudo repertorio di date e di dati. Nulla. Un nulla continuamente sommerso dall’insensatezza del mondo, dal frastuono del presente.»
La nebbia ormai si era ormai alzata, l’orizzonte era limpido. Prima di dirigerci in una vicina trattoria, ci affacciammo sui luoghi della storia: su quelle rive della Sesia, sventrate da una cava, dove un tempo sorgeva il piccolo villaggio di Zardino, distrutto, forse, proprio da una piena del fiume. Sullo sfondo il ponte dell’autostrada. Di Zardino nessuna traccia. Solo la Sesia, ultimo baluardo della memoria, era ancora lì, imponente come sempre con i suoi tre chilometri di argine: perché «la Sesia nasce a 4.OOO metri e in soli cento chilometri arriva fin quasi al livello del mare. Nessuno potrà mai imbrigliarla». Come nessuno potrà mai imbrigliare l’immaginazione. E i matti che decidono di raccontare le storie di un tempo che non c’è più.
Si chiamava Mattio Lovat e voleva salvare il mondo, che in quel lontano 18O5 tumultuosamente precipitava nel nuovo. Si chiamava Mattio Lovat e voleva morire in croce come Gesù per redimere gli uomini dal peccato capitale della modernità. Finì, invece, in manicomio nell’isola di San Servolo a Venezia e fu uno dei primi casi di pazzia studiati dalla psichiatria moderna. Matto, dunque. Sebastiano Vassalli, però, alla scienza medica credeva poco e perciò nel suo romanzo scrisse che Mattio era solo ammalato di pellagra e cioè di quel mal di polenta che tante vittime ha mietuto tra i contadini nei secoli bui della fame.
Sebastiano Vassalli, però, era anche poeta, oltre che narratore attento al vero storico, perciò gli interessava ciò che gli uomini sentono dentro. Per lui Mattio in quel suo sogno di riscatto dell’umanità ci credeva davvero. Marco e Mattio è stato, dunque, prima di tutto un invito al rispetto. Non solo, perché con la sua prosa – limpida, asciutta e rigorosa – Vassalli insinuava anche il dubbio che i matti non sono poi tali e che il mondo, alla fine dei conti, lo mandano avanti loro. Il sacrificio di Mattio, e di tanti altri come lui, forse non è stato vano.
Era il ’92, ci incontrammo a maggio nello stand Einaudi al Salone del libro di Torino. «La follia – disse Vassalli – è l’elemento dinamico dell’umanità. Le malattie mentali in quanto patologia costituiscono una minima percentuale dell’universo dei matti. Il primo dei quali sicuramente è stato quello che, milioni di anni addietro, quando tutti camminavano a quattro gambe, cominciò invece a camminare solo su due. Noi oggi crediamo in una redenzione avvenuta duemila anni fa. Molti al mondo credono che realmente essa abbia raddrizzato le sorti dell’umanità. Mattio, che ha ricompiuto la redenzione, è un matto. Ma chi ci garantisce che anche il primo non lo fosse? Anzi, sicuramente lo era. E specifico che quest’affermazione non è per me bestemmia ma riconoscimento. Lascerei, quindi, la cosa un po’ sospesa, indeterminata. Siamo nell’ambito delle cose che si possono credere o meno. Io rispetto chi crede nella prima redenzione e chiedo di essere rispettato perché, se io credo in quella, credo anche nella seconda. E credo anche che ce ne saranno altre e che ciò sia indispensabile».
– Dino Campana era matto perché era poeta. Antonia, protagonista de La chimera, era matta perché troppo bella per il luogo e il tempo in cui viveva. Qual è, invece, in Mattio la particella originaria di follia che poi muove la sua storia?
«Il germe di follia, che Mattio porta in sé, è l’omosessualità. È l’uscita dalla norma. È lì che la sua strada comincia a separarsi da quella dei propri simili. La pellagra non fa nient’altro che sviluppare questa separazione dandogli uno scenario. Per cui essa, che all’inizio è molto ridotta, diventa poi enorme e la sua infelicità assurge a simbolo di quella dell’epoca: tanto da fargli pensare che il suo sacrificio debba essere grande come le paure, gli sconvolgimenti, i terrori di quel tempo.»
– Ne La chimera il Seicento, nel quale si è formato il carattere nazionale degli italiani. Ora l’età napoleonica. Per quali aspetti tra Sette e Ottocento possono aiutarci a capire quel che sta accadendo oggi?
«Fatti del nostro tempo che ci sembrano enormi – come, per esempio, la caduta del muro di Berlino o la disgregazione dell’impero sovietico – non sono in definitiva che scosse di assestamento di quel terremoto originario che ha colpito l’Europa tra Sette e Ottocento e che ha rappresentato la fine di un mondo. Un mondo in cui tutto si poneva sotto il segno della religione e non esistevano né la politica né la scienza né la psichiatria né i manicomi. I matti, se tutto andava bene, erano soltanto degli indemoniati, come i bambini discoli che venivano raddrizzati dai frati. Si crea, dunque, in quegli anni uno spartiacque importantissimo che è all’origine di tutti i movimenti, di tutte le convulsioni venute dopo.»
– Come il marxismo, per esempio…
«Certo. Il discorso è sempre quello, quello venuto fuori dalla fine di Venezia, quello antico delle illusioni. Allora gli intellettuali si illusero in Napoleone. Noi invece ci siamo illusi nel marxismo: un’illusione dello stesso genere di quella del personaggio del mio romanzo che pensava di cambiare il mondo scoprendo i meccanismi del gioco del faraone. Il marxismo, in definitiva, è stato questo: l’illusione che nel gioco del dare e dell’avere si potesse introdurre un principio di scientificità. Piccole illusioni che si inscrivono nella generale contrapposizione tra il Bene e il Male, in quest’eterna lacerazione che si ripropone continuamente nella storia umana, in questa lotta tra buoni e cattivi che poi, in definitiva, è solo uno scontro tra matti. Marco e Mattio come Faust e Mefistofele: due poveri matti che si trovano alla fine nel posto giusto per loro, nell’isoletta di San Servolo che, con il suo manicomio e lo spettacolo meraviglioso di Venezia, è per me il simbolo della condizione umana e della sua povera lotta tra buoni e cattivi. Ma noi continueremo ancora ad illuderci, nonostante tutto. È indispensabile. Altrimenti l’uomo non potrebbe andare avanti, si intristirebbe e invece continuerà a progredire. A spese dei matti: che seminano illusioni e le vivono e ne sono le prime vittime. In questo senso, però, matti lo siamo più o meno tutti.»
– Ma di questa continua altalena di illusioni e delusioni alla fine cosa resta?
«Nell’ultima pagina de La chimera io cito un verso in cui Gongora dice che dell’uomo dopo la morte resta terra, polvere, fumo, ombra, nulla. Gongora è un pessimista. Io, nonostante le mie storie non abbiano mai un buon fine, credo di essere straordinariamente ottimista perché penso che di un uomo non resta solo terra, polvere, fumo, ombra, nulla ma qualche volta anche la sua storia. E non è poco.»
– Soprattutto se poi c’è chi la racconta. Raccontare storie è un mestiere antico. È cambiato qualcosa in questo lavoro?
«Il patriarca del nostro mestiere era il buon Omero. Di lui nessuno disse che scriveva romanzi storici solo perché all’epoca i racconti si tramandavano oralmente e nel giro di pochi decenni acquistavano già quel tanto di indeterminato e di sfumato che li collocava in una distanza più romanzesca, più letteraria. Ma anche Omero raccontava personaggi esistiti davvero come davvero c’era stata la città di Troia. Raccontare storie oggi, in un’epoca più documentata, piena di archivi, di giornali, obbliga ad una maggiore precisione ma, a parte questo, il mestiere non è affatto cambiato. Il nostro fondatore, però, raccontava sempre la stessa storia. Andava ai banchetti e gli tiravano il sacco delle frattaglie in faccia. Ora, grazie al cielo, noi non andiamo più ai banchetti, non ci tirano il sacco delle frattaglie in faccia e però dobbiamo raccontare storie sempre diverse. Io le piglio dove sono. Cerco di raccontare storie belle, storie importanti e cerco di far parlare tutto perché anche un palazzo, un paesaggio, una città – come in questo caso Venezia – deve diventare personaggio, deve diventare parlante.»
Per continuare a raccontarci la storia sempre uguale ma infinitamente varia di un’umanità condannata a illudersi.
Sebastiano Vassalli, parte seconda, continua – parte prima http://bit.ly/4m3Bif9