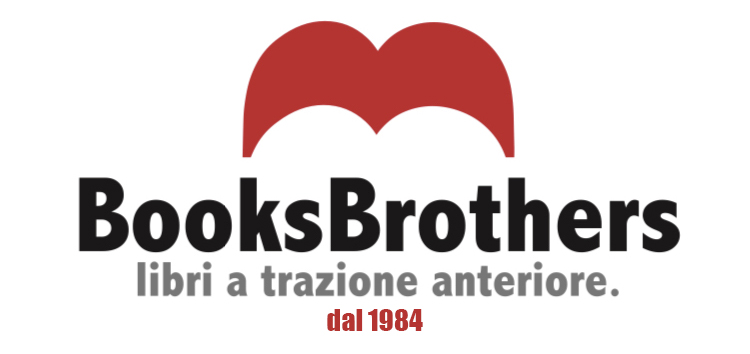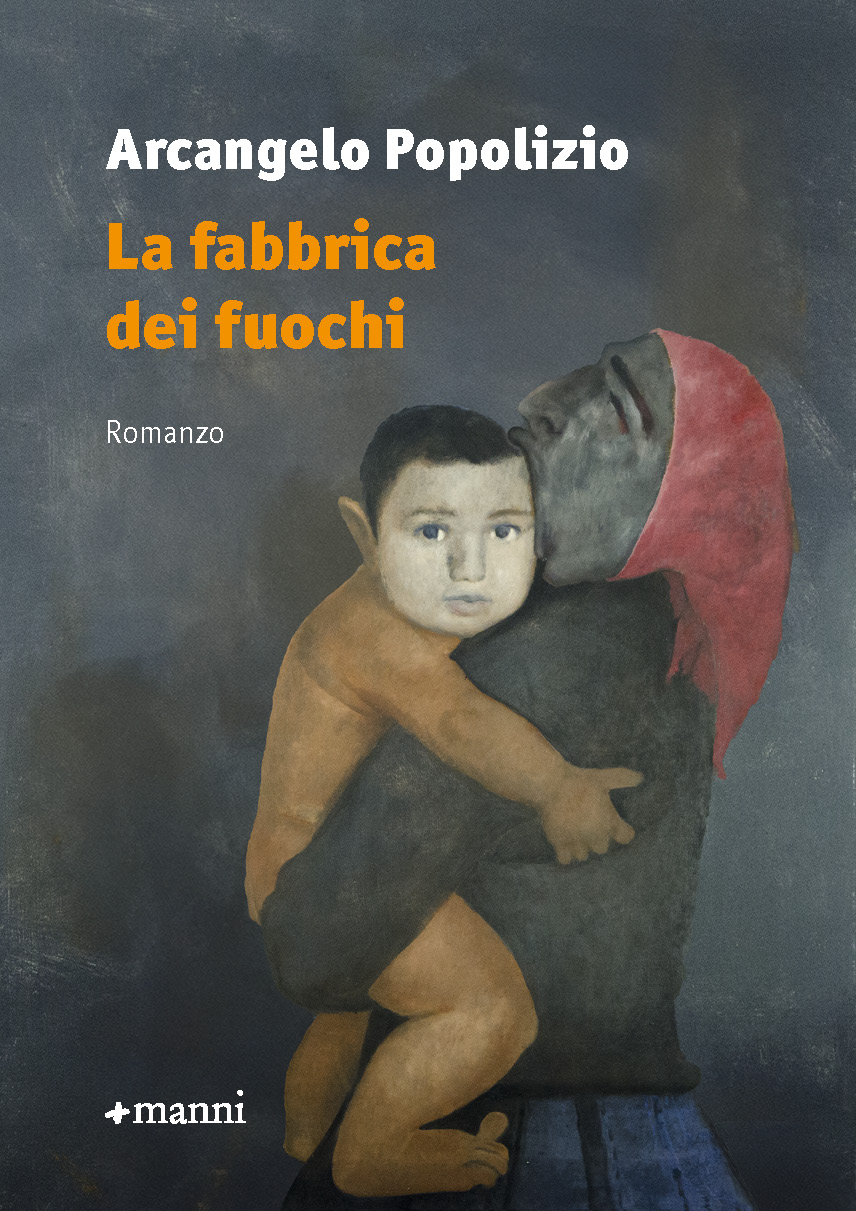
Ne La fabbrica dei fuochi di Arcangelo Popolizio saltano in aria tante illusioni. Purtroppo, non solo quelle. Anzi. L’inizio è drammatico, e di romanzesco c’è solo la descrizione visionaria del paesaggio: «Nella lieve brezza del mattino (tutto sembrava) calmo e vitale eppure Carlo percepiva una battaglia silente: quelle erbe si sovrapponevano, si scalzavano, si scostavano e inerpicavano togliendo luce l’una alle altre. Vedeva scorrere ai margini della strada un rivolo di sangue verde frutto di una guerriglia per l’esistenza che a tratti inondava la ghiaia».
- È domenica, c’è la festa del paese. Lasciati i due figli a casa, Anna e Carlo vanno alla fabbrica dei fuochi di un parente che è in ritardo con le consegne e li ha pregati con una certa insistenza di dargli una mano. Peraltro i due sono in debito con lui che gli ha prestato i soldi per sposarsi. Prima di arrivare c’è tempo per ricordare la propria storia matrimoniale. Contrasti familiari, figlio in arrivo, fuga a Roma, rito civile. L’atto romantico e di ribellione seda le incertezze di Carlo, «perennemente al bivio» tra il sogno di una vita da scrittore scapigliato, tipo Henry Miller a Parigi, e la «necessaria adesione al reale». Poi i giorni, gli anni, uno dopo l’altro, insieme, marito e moglie, e con essi l’equilibrio sempre precario ma vitale di «un amore imperfetto e appassionante che sfidava le più intime incapacità».
Tutto, però, finisce quella domenica. La fabbrica dei fuochi salta in aria. Un incidente sul lavoro, oppure? Non sempre la verità è dietro l’angolo. Lei aveva trentadue anni, lui quaranta. Nella prima nota in appendice al romanzo l’autore scrive: «Il racconto è stato ispirato dalla tragica vicenda dei miei nonni materni morti nella esplosione di una fabbrica di fuochi di artificio a Modugno nel lontano settembre del 1959».
Protagonista e voce narrante è il più grande dei due figli di Anna e Carlo. Paolo, ormai adulto, affermato musicista, dopo aver vissuto a Firenze, decide di tornare nella propria città natale e di acquistare la casa di famiglia dove ha trascorso infanzia e prima giovinezza. Il romanzo è, quindi, il suo viaggio indietro nel tempo nel tentativo di ricomporre i tasselli della memoria ridotti a brandelli da quell’esplosione. Ricchissimi gli sviluppi narrativi: avventurosa la trama, ampi e documentati i momenti descrittivi, acuti gli approfondimenti psicologici, raffinati i riferimenti culturali, dinamica la forma con alcune ardite incursioni in versi e qualche citazione dialettale.
- Paolo cresce in un gineceo di zie, affidato alle cure della più giovane fra loro, nubile e refrattaria ai formalismi bigotti del tempo e del luogo. Il ragazzo comincia così la sua educazione sentimentale, che conoscerà uno sviluppo decisivo grazie ad un’eccentrica coppia di intellettuali, Chiara e Lorenzo, inquilini dello stesso palazzo, lui professore di latino, lei musicista. Con la loro entrata in scena nell’intreccio riverbera l’eco di alcuni classici dell’Ottocento. Nessuna anticipazione. Leggere per credere. Solo un’avvertenza, attenzione: in cauda venenum, la citazione in latino è d’obbligo.
Chiara e Lorenzo sono spiriti irrequieti e libertari. Siamo nel pieno del clamore politico degli anni settanta. Tutto sembra in gioco. O un gioco. Anche norme e costumi radicati. La famiglia tradizionale, per esempio. C’è voglia di libertà, a cominciare dai rapporti sessuali. Qualcuno scommette su una rivoluzione armata, e agisce di conseguenza.
Chiara e Lorenzo sono aperti al nuovo e nel cenacolo intellettuale della loro casa ne discutono con amici. In quel trambusto di cambiamenti tutti cercano la propria misura. Anche Paolo. Anche Altamura. Destini incrociati, i loro: «Ho 18 anni e quando mi sento scivolare in basso ho un rimedio: mi aggrappo alle mura di questa città che si apre sotto il mio sguardo come un codice amanuense pieno di infiniti dettagli».
Altamura è protagonista e regina del romanzo. Nel bene e nel male. Il palazzo di via Solofrano con il suo «bel finestrone alla romana» è un faro sulla città. Amanuense anch’egli, Popolizio si esercita in deliziose minuzie calligrafiche della quotidianità e della storia della «Leonessa di Puglia». Per esempio, il rito, più che tecnica, della lavorazione del pane e di certi suoi formati particolari, una vera «festa della creazione… Al tramonto una delegazione della famiglia va a ritirare le forme di pane ancora caldo dal forno. È lì che per la prima volta vedo emergere dalla penombra delle pareti annerite dalla fuliggine, uno strano oggetto ricavato per gemmazione dalle pagnotte madri: “u peccelatidd”».
Ci sono poi nel romanzo chianche, claustri e pisuli, masserie e Jazzi, prete e scaldaletto, le serenate alle donne corteggiate, il teatro Mercadante e il Padre Peppe, la cupola di San Domenico e l’orologio del Cagnazzi, piazza Zanardelli e piazza San Giovanni. C’è la festa dell’Unità del 3 ottobre 1975 che quell’anno, insieme a panzerotti, panini, capitelli di salsiccia e le consuete maratone di incontri sociologici, sindacali e politici, propone una coraggiosa e dissacrante mostra di Domenico Ventura, rimasta nella memoria collettiva come uno spartiacque culturale per l’acceso dibattito provocato. Né mancano nel racconto i meandri feroci e oscuri di soprusi e violenze padronali di stampo feudale. Si fa presto a scadere dalle icone al folklore se alla passione non s’accompagnano competenze adeguate e quelle di Arcangelo Popolizio spaziano dall’architettura (suo ambito professionale) all’etnografia.
- La fabbrica dei fuochi è il romanzo di un sogno generazionale che considerava imprescindibile vento della libertà musica, letteratura ed arte. Un filo rosso tra le pagine è la fitta trama culturale che scandisce la formazione di Paolo: da Mozart a Gato Barbieri, da John Coltrane e Keith Jarrett ai Pink Floyd; da Rilke a Virginia Woolf, da Tommaso Campanella a Giordano Bruno, da sir Thomas More a Proudhon, Bakunin e De Sade, tanto per fare alcuni nomi.
Con l’esplosione che uccide Anna e Carlo, insieme alla fabbrica salta in aria ogni illusione e, leggendo le ultime pagine del romanzo, bisogna prendere atto che (dura lex, sed lex) non c’è condizione sociale, né scelta politica, adesione ideologica o conquista culturale, non esiste mai, da nessuna parte, superiorità etica di alcuni su altri. Migliori non ce ne sono. Solo diversi. Ognuno col suo specifico fardello di luci e ombre, colpe e virtù e la voglia, la necessità, il dovere di rischiarare un po’ il buio dentro e intorno a sé, riconoscendo ed esercitando il proprio talento. Per esempio quello della scrittura. Come ha fatto Arcangelo Popolizio.
Arcangelo Popolizio, La fabbrica dei fuochi, Manni