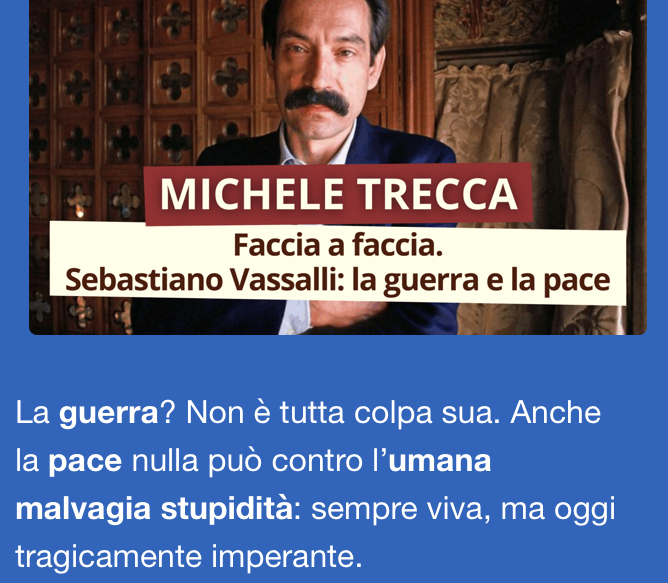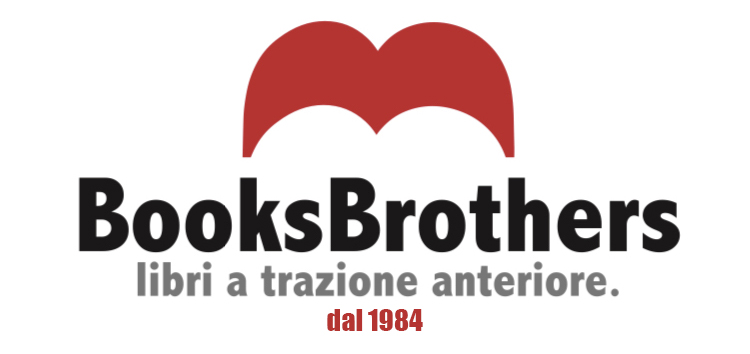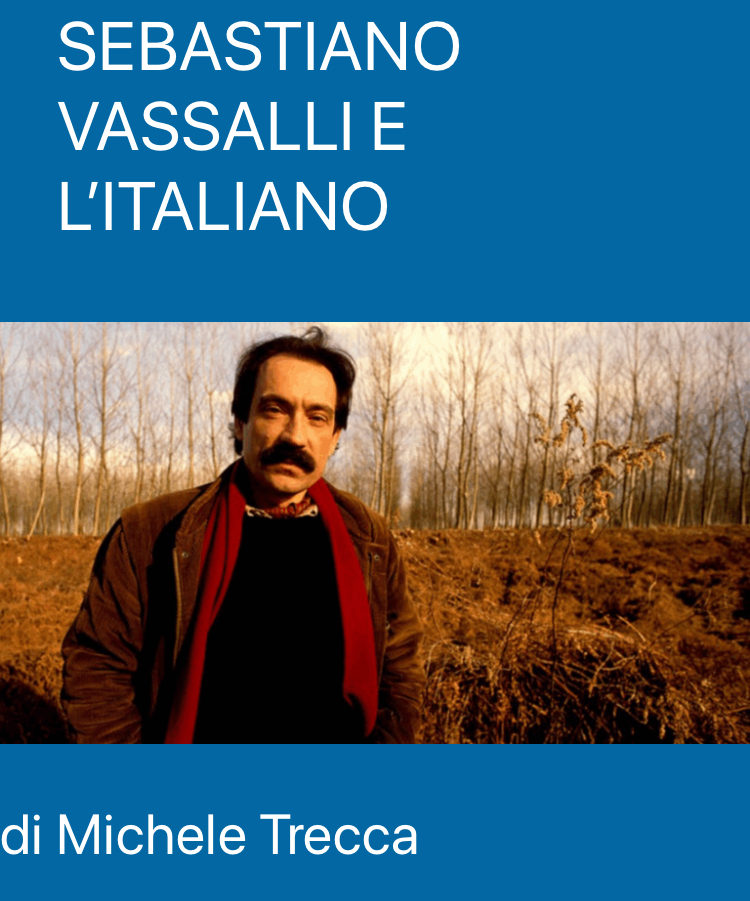
Faccia a faccia – incontri, letture, miti letterari – Sebastiano Vassalli e l’Italiano
Era il ’92, e per l’intervista su Marco e Mattio[1] ci incontrammo a maggio nello stand Einaudi al Salone del libro di Torino. Niente Pisnengo, quella volta lì, e niente trattoria dove un paio di anni prima avevamo pranzato insieme dopo aver parlato di Antonia e de La chimera.
Poi non ci siamo più visti. Da un po’ di tempo ero tornato al Sud. Le interviste ormai si facevano via mail. Chi sentiva delle mie scorribande al Nord, per ascoltare faccia a faccia parole d’autore, non capiva e mi dava dello sciocco.
Ho continuato a ricevere i tuoi libri: firmati, spesso con dedica ed ex libris, che erano tutt’uno con il romanzo. Erano il tuo suggello impastato con la storia nella compattezza di un segno. Come ti ho detto[2], non trovo più il libro ma ricordo bene la cometa che apriva il romanzo su Campana. Ho invece sotto gli occhi la chimera per la giovane e bella strega di Zardino, il leone di Venezia per Marco e Mattio e poi un cigno per il titolo omonimo e i tre sbuffi d’onda celesti di Mareblù.
- L’ultimo libro con la tua firma è Maestri e no del 2012. Ora che li conto mi sembra strano che siano passati tanti anni senza vederci. Un’infinità di parole ci scivolano addosso e si perdono, le tue no, perché le tue sono in arte le parole di un grande italiano. Basta una manciata dei tuoi romanzi a fare una controstoria del nostro Paese. Da Il Cigno a Cuore di pietra, passato prossimo, ad Archeologia del presente e L’Italiano, presente progressivo. Tempi e registri letterari diversi, passo cadenzato nei primi due (tipo La chimera e Marco e Mattio), modalità swing negli altri come già ne L’oro del mondo e, prima ancora, in Mareblù del periodo sperimentale, non a caso riedito nel 1992 in versione riveduta e ampliata.
In un percorso ideale di rilettura delle nostre vicende nazionali, Mareblù, Archeologia del presente e L’Italiano sono sia il capolinea cronologico della tua ricostruzione storica sia alta espressione di quella modalità giocosa e irriverente del tuo disincanto, sempre viva sotto traccia insieme all’altra più paziente e circostanziata di documentate argomentazioni.
- Il Cigno affonda il colpo nel male più vistoso e forse più antico del nostro paese, ancora tragicamente e beffardamente attuale. Palermo, 1893-1920. Il romanzo della mafia, dice il risvolto di copertina. Ed è così. Il Cigno, infatti, racconta le gesta e l’alterna fortuna di Raffaele Palizzolo, deputato e capo cosca siciliano, imputato, condannato a trent’anni per l’omicidio del commendatore Emanuele Notarbartolo e poi assolto per insufficienza di prove.
Nel 1993, quando venne pubblicato il romanzo, in Italia erano in corso le inchieste giudiziarie di Mani pulite e l’aria tremava ancora per il tritolo di Capaci e via D’Amelio. Il Cigno racconta fatti di un secolo prima ma le sue pagine sono un mare limpido scrutando il quale puoi vedere sul fondo l’eterno ritorno di dinamiche sempre uguali. Basta solo aprire gli occhi, ma ci vuole onestà e coraggio.
Siamo ai tempi dello scandalo della Banca romana e a Palermo, al Banco di Sicilia, gli amici di Crispi stampavano soldi falsi per coprire tutto. Notarbartolo, allontanato nel ’90 dalla direzione dell’istituto di credito dell’isola, stava per farvi ritorno, chiamato dal nuovo presidente del consiglio, marchese Di Rudinì, con il preciso scopo di cacciare i ladri.
- Un’ammazzatina come tante. Accade, però, l’imprevedibile. Scoperchiato il calderone del malaffare politico, «le persone oneste avevano ricominciato a sperare» e al processo di secondo grado tenuto a Milano la deposizione del figlio della vittima, che accusa apertamente il deputato siciliano, infiamma l’opinione pubblica, scatenando l’opposizione socialista e l’attenzione dei mezzi di informazione. Saltano gli antichi equilibri e per la prima volta «un Tribunale dello Stato arriva a certificare, con una sua sentenza, la realtà di un’associazione segreta chiamata mafia».
È la fine di Palizzolo? Neanche per sogno. In sua difesa, infatti, insorge la Sicilia tutta. A cominciare dagli uomini di cultura i quali, sentendosi ingiustamente diffamati dal complotto del Nord, costituiscono un comitato per difendere il buon nome dell’isola e ottenere la revisione del processo. Che – a distanza ormai di undici anni dal fatto – si celebra per la terza volta a Firenze e si conclude con l’assoluzione del deputato per insufficienza di prove. Dopo cinque anni di carcere, il Cigno rientra a Palermo in un tripudio di folla.
È l’apoteosi, ma non passano tre mesi e il Bardo, l’eroe nazionale siciliano, viene sconfitto alle elezioni politiche e ben presto finisce nel dimenticatoio, ridotto al rango di farneticante macchietta, allontanato da tutti e inseguito per strada dai bambini che gli chiedono di recitare i suoi patriottici e altisonanti versi.
Una conclusione degna di una commedia di Pirandello, annota Vassalli nell’epilogo per interposta persona. E, così facendo, ha lasciato a noi la patata bollente da spelare. Giustamente: poiché compito della letteratura è porre domande, non dare risposte. Il narratore racconta, chi vuole poi tira le somme. E Vassalli è stato fin troppo generoso nella sua funzione di regista e guida: ha tenuto il campo con disinvoltura e come un infaticabile playmaker ha smistato luoghi e termini (siciliani, con testo a fronte), personaggi e carte giudiziarie, nodi storici, culturali e sentimentali, dando vita ad un impasto corale grazie ad una sorprendente familiarità con una realtà per lui allora insolita, essendo Il Cigno la sua prima sortita fuori dalle brume nordiche. Insomma: Vassalli ci ha accompagnato per mano fino a mettendoci di fronte alla sostanza nuda della questione.
- Questa: come è stato possibile che in un momento cruciale della propria storia un popolo intero – documentate, come tutto il resto, anche le eccezioni – abbia scelto la parte sbagliata? Fino ad investire i propri carnefici di una rappresentatività tale da farli illudere di essere innocenti oltre che impunibili. Un gigantesco e tragico equivoco: ma non certo casuale, e comunque decisivo.
Un assurdo abbraccio: come quel sincero e convinto sentimento materno che – tra sensi di colpa e nuovi e sconosciuti ozi e agiatezze – la popolana Filicetta pian piano matura nei confronti dell’amante Palizzolo, che le ha comprato la salvezza e la mantiene per sé e per gli amici tra cui anche il responsabile della morte del marito – trucidato con altri scioperanti durante i moti organizzati dai Fasci dei lavoratori il 3 gennaio 1894 – e killer di Notarbartolo, tale Piddu facci di lignu, anche lui poi assolto. E dunque: com’è stato possibile?
Ci sono, ovviamente, le responsabilità della politica, rappresentate da Crispi, figura centrale del romanzo. Lo statista, in punto di morte, ripercorre la propria vita, ricordando fra l’altro quando era stato convocato da un giudice di Bologna e accusato di essersi appropriato di grosse somme del Banco di Napoli. Perché quel «cretino pensava che la politica interna ed esterna di una nazione moderna potesse farsi senza quattrini e senza infamia, soltanto con l’onestà: ci voleva ben altro!» per fare grande l’Italia, vera ossessione dello statista, nemico giurato dei micromani alla Giolitti. E poi: «Il giudizio politico su un uomo (Notarbartolo), e la sua morte, in uno Stato costituzionale sono due fatti distinti e inconciliabili».
Spettava allora agli intellettuali e alla classe dirigente saldare il conto delle responsabilità e connivenze, distinguere ed evitare vischiosi intrecci all’ombra di alibi giudiziari, distorte concezioni della politica e facili luoghi comuni. Ma essi minimizzarono – come il prof. Pitrè, famoso antropologo – riducendo la mafia a un semplice fatto di costume: «La cosiddetta mafia non è altro che la coscienza, un poco esagerata, che i siciliani hanno della loro personalità, del loro onore e della loro dignità…».
Naturale, quindi, quel sentimento popolare di Filicetta e di tutti di «rabbia contro quegli stupidi italiani del nord, che pensavano di poter spiegare quanto accade in Sicilia con un’unica parola: mafia…». Non è dunque solo paura e omertà, la famiglia e i figli. «Forse – pensa un giornalista a colloquio con il Cigno – i guai della Sicilia sono causati da quest’immensa distanza che c’è qui, tra le parole e le cose… Due mondi lontanissimi e completamente estranei! Qui chi agisce a suo vantaggio è sempre nel giusto… mentre la ragione… è condannata a perdersi in un labirinto di sofismi…».
Eppure è tutto semplice: una morte violenta separa definitivamente il bene e il male con una linea di sangue, al di qua o al di là, altre possibilità non ci sono. A zittire i sofismi della ragione dovrebbe bastare la cruda materialità di certe mattanze. Non ci può essere tra gli uomini una distanza tale per cui alcuni, come Crispi, nel loro delirio di onnipotenza, possono addirittura illudersi di non morire mai e altri invece debbano morire in un modo che ancora offende: «Alcuni di quei corpi urlavano, scalciavano, rimbalzavano sull’acciottolato come se avessero avuto dentro di sé una molla invisibile; alcuni agonizzavano, spalancando la bocca o rompendosi le unghie e i polpastrelli contro i sassi della strada nel tentativo di afferrare ciò che gli stava sfuggendo, e che non sapevano nemmeno più cosa fosse; alcuni, infine, erano fermi in posizioni scomposte, con le gambe e le braccia sottosopra e gli occhi spalancati in un’ultima domanda: Cosa mi è successo?»
Cosa ci è successo? E ancora: cosa ci sta succedendo? Quando, su Capaci e via D’Amelio, avremo carte processuali con la stessa forza di verità di un romanzo come Il Cigno? Chissà. Eppure il romanzo di Vassalli è stato ispirato da un documento parlamentare: Nel regno della mafia di Napoleone Colajanni, stampato nel 1900 dalla Camera dei deputati[3].
Chi crede che la letteratura e le altre arti siano le massime espressioni della bellezza e della civiltà umana, non può non illudersi che esse possano fermare anche le armi.
- Prima guerra mondiale, ogni sera da un caposaldo italiano sul fronte a 1.400 metri scende a valle un portaordini. O, meglio, dovrebbe. Il malcapitato di turno, infatti, viene subito inquadrato dalle fotoelettriche austriache e impallinato. Ne sono stati ammazzati già tre, quando l’incarico tocca al napoletano Pasquale Esposito. Il quale, più morto che vivo dalla paura, anziché nascondersi, si mette a cantare con bella voce di tenore. Partono le note (Che gelida manina, se la lasci riscaldar…), tacciono le armi e fioccano gli applausi, da una trincea e dall’altra. Arrivato in fondo al vallone, Caruso s’inchina, ringrazia ed esce di scena. Come fosse a teatro.
Anche Cuore di pietra (1996) è una romanza e appartiene al teatro. Con un colpo di bacchetta magica e lo stesso effetto di suggestione del suo Caruso, Sebastiano Vassalli ha ridotto la nostra storia nel palcoscenico di una casa e si è messo a cantare le alterne vicende del popolo italiano attraverso le vite effimere (come tutte, del resto) degli abitanti di una dimora patrizia costruita nel 1860 in una «città piuttosto piccola che grande, piuttosto brutta che bella, piuttosto sfortunata che fortunata e però… piuttosto felice che infelice».
Il cuore di pietra del titolo è quello di casa Pignatelli, sontuoso parto della fantasia di un architetto geniale e megalomane e silenziosa testimone del pigro avvicendarsi di anonime generazioni talora scosse dal loro torpore da sogni improvvisi. Come, per esempio, quello del progresso o modernità, che a fine secolo portò insieme la duplice novità delle banche e dei manicomi: «due facce di uno stesso fenomeno… i soldi facevano girare il mondo sempre più in fretta, e la fretta faceva impazzire gli uomini…».
La prima banca popolare della nostra città ai piedi del Monte Rosa nacque, manco a dirlo, da una riunione di notabili al primo piano di casa Pignatelli. In quelle stesse stanze che poi vedranno i bivacchi delle camice nere dell’Uomo della Provvidenza e nel secondo dopoguerra, invece, alloggeranno il nuovo partito della Democrazia Cristiana. E così di seguito, in uno stretto intreccio di privato e pubblico, amori e affari, fino ai giorni nostri: quando la casa – specchio fedele della parabola del Paese – cade nell’abbandono e nel degrado, vittima di speculatori e abusivi vari.
O, forse, solo del tempo e del suo inesorabile e insensato ciclo di creazione e distruzione: «È lui che ci parla con la nostra voce, che ci guida, che manipola i nostri desideri e i nostri sogni e alla fine cancella la nostre vite per sostituirle con altre vite, di altri uomini che noi non conosceremo mai. È lui che ci fa credere di essere il centro e la ragione di tutto, mentre ci ispira comportamenti e pensieri così stupidi che gli Dei ne ridono ancora…».
Con Cuore di pietra la morale laica conosce uno dei suoi approdi narrativi più limpidi e alti. Più accattivanti. Caruso ha cantato contro la morte (le pagine di un romanzo sono l’unica forma di eternità concessa all’uomo), rubando agli Dei (quelli di Omero) un po’ del loro riso. Come Violino (cognome, non soprannome) che vendeva giornali strillando notizie inesistenti: «Tragedia in Cina: le donne non la dànno!… Il Papa annuncia dalla finestra: pioverà e cresceranno funghi un po’ dappertutto!… Ultimissime della notte: zanzare assetate di sangue cercano culi scoperti!… Oppure: Il Duce ha detto: oggi è venerdì e io vi prometto che domani sarà sabato, dovesse cascare il mondo!… Ultimissime dai fronti: era tutto uno scherzo!»
Appunto: e se fosse tutto uno scherzo? E se fosse solo uno scherzo anche tutta l’umana vicenda alla quale tanto faticosamente ci sforziamo di dare un senso? Gli dei giocano in cielo con le nubi, noi qui in terra giochiamo a fare la storia. Ma quand’essa poi volge in tragedia, allora ci mancano le parole. Come a quel giornale, il più grande d’Italia, che dopo l’8 settembre ’43 uscì con un editoriale dal titolo Conosci te stesso che era l’esatta trascrizione della voce Italia dell’enciclopedia. Altro che le burle di Violino.
Per fortuna ci sono i romanzieri, a porre rimedio alle sciocchezze e ai silenzi della stampa. Aiutandoci a capire qualcosa di quel che siamo.
E allora, chi siamo… noi, oggi? Degli idioti, ecco quel che siamo. «Che idioti!», questa sintesi liquidatrice dell’utopia rivoluzionaria che ha investito e travolto la generazione del ’68 è una conclusione romanzesca politicamente scorretta che pochi si sono potuti permettere senza incorrere in strali pregiudiziali e ideologici. Michel Houellebecq in Francia e Sebastiano Vassalli in Italia. Sia l’uno sia l’altro con la coraggiosa e onesta trasparenza della propria scrittura hanno conquistato da subito un’autorevole extraterritorialità artistica per cui le loro sferzate critiche hanno sempre ottenuto un salutare effetto provocatorio.
- Archeologia del presente abbraccia gli ultimi trent’anni della nostra storia (dal 1970 ad oggi) ed è in pratica un’operazione revisionista di ricapitolazione di tutti i movimenti politico-sociali di questo periodo (perciò l’accostamento a Houellebecq). Dalla didattica alternativa all’antipsichiatria al femminismo, dalle lotte ecologiche a quelle pacifiste ed antirazziste: i due protagonisti, Leo e Michela, non perdono occasione per tentare «di cambiare il mondo in pochi anni, correggendone gli errori e facendolo diventare perfetto». Il comprimario e io narrante, invece, dopo avere condiviso con la coppia un breve e caotico periodo di lavoro in un istituto tecnico (come nella realtà dei fatti lo stesso Vassalli), abbandona ogni velleità rivoluzionaria preferendo occuparsi della propria attività professionale di architetto («I tavoli da disegno… con i loro tecnigrafi e le loro righe millimetrate… rappresentano la ragione, la misura, l’ordine»).
Pur nella diversità delle scelte di vita, egli, però, mantiene un’affettuosa consuetudine con i due amici per cui, quando la loro avventura avrà un esito drammatico, si sentirà in dovere di testimoniare l’eccezionale caparbietà con cui essi hanno «continuato ad illudersi e sognare, quando tutti, ormai, si erano svegliati e dopo che le illusioni erano passate di moda, urtando contro ogni genere di ostacoli e andando incontro a mille sconfitte: come due mosche imprigionate in una stanza che continuano a battere e a ribattere contro il vetro dell’unica finestra, perché di là dal vetro c’è il sole, c’è il cielo, c’è lo spazio infinito che loro non possono raggiungere…».
In Archeologia del presente i nomi dei luoghi sono cancellati dagli asterischi, i movimenti interiori allontanati sullo sfondo per fare posto a quelli collettivi. Vassalli raffredda la materia calda del presente procedendo con ritmo documentario e divulgativo, tipo Superquark, ma incanta con la disarmante simpatia e affabilità dei due protagonisti in continuo contrasto con il buon senso dell’io narrante (vedi l’inno all’Aspirina in contrapposizione a macrobiotica e omeopatia) e la sua critica pungente ma sommessa nei confronti delle inutili battaglie dei donchisciotteschi amici.
- Archeologia del presente è il burbero, ironico, disperato e affettuoso manifesto del degrado entropico della nostra specie, consumata dal bi-sogno ontologico di credersi diversa da quello che è, di credersi cioè in grado di dirigere il corso del mondo opponendosi alla «sovrana indifferenza» delle cose.
Leo e Michela sono portavoce di un’istanza corale, ennesimi epigoni o vittime sacrificali di quell’inestirpabile genìa di «idioti che in ogni epoca hanno speso le loro vite per far diventare il mondo perfetto, e che a prezzo di sofferenze e di enormi fatiche sono riusciti a portarlo dov’è adesso, cioè sull’orlo del baratro».
Due idioti simili «a quelle migliaia di uomini e di donne di cui si parla nelle enciclopedie e nei libri di storia. Ai santi, agli inventori, ai condottieri, agli artisti, agli scienziati, ai redentori, ai rivoluzionari, agli eretici, ai martiri di tutte le fedi e di tutte le cause, ai pionieri di tutte le trasformazioni». Leo e Michela erano due idioti ma i loro occhi erano pieni di sogni, quelli del loro assassino invece vuoti e inespressivi. E i nostri, oggi?
Con uno scatto corsaro prima del traguardo, in una nota breve, fitta e minuta, nella pagina conclusiva, come titoli di coda, l’io narrante tributa a quei due idioti dei suoi amici la struggente standing ovation di un ultimo elenco delle loro illusioni e lotte:
«Post-scritto. Dopo aver scritto la storia di Leo e Michela, e dopo averla riletta, mi sono accorto di non aver parlato di alcune loro imprese, di cui so poco e che considero meno importanti di altre. Non ho detto, per esempio, che da giovani i miei amici sono stati visti davanti al Teatro alla Scala di Milano a lanciare uova contro le signore in pelliccia, per protestare contro le differenze di classe e contro lo sterminio degli animali; che in diversi momenti della loro vita si sono prodigati, con tutte le loro energie e con tutto il loro entusiasmo, per mandare cibo e medicinali a una mezza dozzina di popolazioni africane stremate dalle guerre, dalle epidemie e dalle carestie; che si sono battuti contro la produzione e il commercio, nel nostro Paese, delle armi da guerra e particolarmente delle mine anti-uomo; che hanno partecipato alle raccolte di firme e alle campagne stampa per la liberazione dal carcere di alcune persone ingiustamente condannate (sull’ingiustizia di quelle condanne, loro non avevano dubbi), e per il rimpatrio di alcuni italiani detenuti all’estero. E poi, non ho detto che sono stati attivi in varie associazioni di volontariato, per l’assistenza ai drogati e agli alcolizzati, per il reinserimento nella società degli ex detenuti, per finanziare la ricerca scientifica contro il cancro, l’Aids e altre malattie considerate incurabili. Alla loro morte gli sono stati tolti i reni, gli occhi e non so che altro: tutti gli organi, insomma, che non erano stati lesi dalle pallottole, e che potevano ancora servire a migliorare la vita di un’altra persona. Soltanto dopo che si è compiuta questa loro ultima volontà, manifestata già da molti anni, i corpi di Michela e Leo sono stati bruciati. E questo è, in sintesi, tutto ciò che sapevo di loro e che ancora non avevo detto».
E tu, lettore, se non piangi di questo, di che pianger suoli? «I grandi moralisti e rompicoglioni, come Leo e Michela, appartengono a tutti: sono, per così dire, un patrimonio della collettività». Nessuno mai, più di Sebastiano Vassalli, ha saputo raccontare, criticare e amare, questo impagabile bene comune.
Si diceva un tempo sbeffeggiando il potere: una risata vi seppellirà. Così è stato. Sbagliato solo il complemento oggetto. Quella risata tanto attesa ha seppellito, infatti, ogni sogno e voglia di cambiamento e rivoluzione. Era già tutto previsto, nero su bianco, in Mareblù (1980/1992) che si conclude, appunto, con una risata liberatoria, la prima della sua vita, del protagonista Augusto Ricci, custode del camping che dà il titolo al romanzo.
Augusto si ritiene vessato dal suo datore di lavoro, il capitalista Indrago. Questi, invece, sostiene che da trent’anni lui bivacchi e spadroneggi nella sua proprietà infastidendo gli ospiti, in particolare le donne, spiate nell’intimità con «il binocolo a prismi ottici Zeiss». Un progetto di riconversione del camping in villaggio di alto profilo è l’occasione per regolare i conti tra i due. Il pendolo narrativo oscilla tra licenziamento e vendetta. Finisce pari e patta con un beffardo e caustico «Proletari e capitalisti uniti nella lotta».
- Mareblù è una commedia esilarante, eretica, rigorosa e ricca di spunti storici e bordate contro i luoghi comuni del politicamente corretto, seppelliti con l’esplosiva risata finale di Augusto – duro a parole, inerme nella realtà – la cui resa di fatto oscura i ritratti da sempre nella sua stanza dei «cinque giganti della storia» (Marx, Engels, Lenin, Stalin e Mao) e tacita il pappagallo Spartaco pronto ad ogni piè sospinto ad intonare Bandiera rossa.
Mareblù meritava di essere quel che sarebbe dovuto essere, «un film con Augusto Ricci – il PCI – interpretato alla perfezione, anche se in modi diversi, da uno dei nostri quattro attori nazionali (in ordine alfabetico: Gassman, Manfredi, Sordi e Tognazzi): di cui è coetaneo». Non è mai troppo tardi. C’è ancora tanto da ridere.
Anche perché l’Italiano continua a non conoscersi o a far finta di non sapere chi è, e continuerà così fino all’eternità. «Chi, io?» messo alle strette dopo sollecitazioni varie, così Vassalli ha immaginato che risponderà l’Italiano all’appello dei popoli il giorno del Giudizio Universale. Eccolo, allora, L’Italiano (2007) a tutto tondo in dodici racconti che chiudono il cerchio della nostra autobiografia nazionale, dall’Ottocento ad oggi. Ecco, allora, la storia ufficiale di quel che siamo: affettuosa e spietata, irrinunciabile e definitiva. Sontuoso riepilogo di un quarto di secolo di attività letteraria del nostro autore contemporaneo più rappresentativo e importante, ancora oggi, a dieci anni dalla morte.
- Nei racconti del libro, come in un florilegio, tornano in una nuova veste o luce temi e personaggi già affrontati nei precedenti romanzi. L’Italiano è l’indice ragionato di un ipertesto grande quanto tutta l’opera di Vassalli; l’esplicitazione di un progetto di ampio respiro, chiaro all’autore sin dal 1980 con la pubblicazione di Mareblù e da lui perseguito nel tempo con varietà di registri e il sudore, il rigore e il talento artigianali di quelli che una volta si chiamavano Maestri. Ogni romanzo un tassello del carattere nazionale italiano: con L’Italiano giù la tela, ed ecco un volto possibile per la nostra ombra.
Il primo racconto, Il doge, affronta il tema dell’irruzione della modernità. Come già in Marco e Mattio (1992), siamo a Venezia, è l’inizio del nuovo secolo, l’Ottocento, e Ludovico Manin, l’ultimo doge, uomo onesto e probo, spodestato dai rivoluzionari sostenuti e poi traditi dai Francesi, si imbatte in una folla che lo sbeffeggia e offende: non sanno cosa vogliono ma… lo pretendono: «Se c’era ancora una via di saggezza, pensò il Doge, soltanto loro: i diversi, i lunatici, gli strambi, avrebbero potuto indicarla. La ragione umana aveva fallito».
Rotti gli argini della tradizione, comincia la corsa dissennata al progresso, la nuova illusione (dismessa quella dell’aldilà) di sorti (in terra) magnifiche e progressive. Alla follia dell’arte il compito di ricordare all’uomo la verità della sua condizione e tenere vive quelle domande fondamentali che (al contrario di risposte e certezze) danno sapore all’esistenza.
L’Italiano, invece, vuole essere grande, oltre i propri mezzi, con qualunque mezzo. Ecco, allora, ne Il padre della patria, Francesco Crispi, capostipite di una progenie di nazionalisti che arriva fino a Craxi, colto in un’epica agonia, degna della statuaria grandezza sudamericana di un patriarca di Marquez. Crispi è l’equivoco italiano di sempre (da Macchiavelli in poi) dell’autonomia della politica al di là del Bene e del Male. Ma italiano è anche l’incanto dell’arte di Caruso (Il tenore), tra le pagine più belle di Cuore di pietra (1996).
- L’Italiano ha tante facce, di ogni tipo, come quelle riportate in copertina da un’illustrazione pop di Andrea Pazienza. L’Italiano, per dirla tutta, è un trasformista, come l’ex ispettore di polizia Saverio Polito, incaricato alcuni giorni dopo il 25 luglio del ’43 di scortare in due momenti diversi Benito Mussolini e sua moglie Rachele in luoghi lontani dalla guerra. Da fedele ufficiale, quale era conosciuto dai due coniugi, a sfrontato molestatore dell’illustre signora: Polito è un compendio della repentina e fortunata migrazione antifascista dell’Italiano, già analizzata da Vassalli ne L’oro del mondo (1987).
L’Italiano, infine, ha trovato la propria incarnazione ne l’Arcitaliano, colui che ha unificato nel sogno comune della ricchezza il paese legale e quello illegale. L’Arcitaliano è riuscito nel Miracolo di intercettare quei capitali che prima fuggivano all’estero attraverso uomini come Sindona, Calvi e Marcinkus. Forse è stata la Madonna o forse, scrive Vassalli nell’ultimo brano che è una conversazione con se stesso, è stata un’altra entità che comincia sempre con la M.
L’Arcitaliano siamo noi: «È la nostra esagerazione. Chi lo ama, vorrebbe essere come lui, anzi: vorrebbe essere lui. Chi lo odia, ha molti dei suoi difetti senza avere le sue ville in Sardegna, i suoi capelli trapiantati e il suo potere… lui e loro sono due prodotti diversi e opposti della storia di questo paese e delle sue anomalie».
Nell’opera di Vassalli politica e letteratura si incontrano sul terreno comune della storia offrendo a noi lettori, almeno per un po’, il prezioso, imprescindibile piacere di conoscere e vivere appieno il nostro tempo e la nostra condizione umana.
[1] https://www.ilmondonuovo.club/faccia-a-faccia-sebastiano-vassalli/
[2] https://www.ilmondonuovo.club/sebastiano-vassalli-un-babbo-matto/
[3] https://editoria.letteratura.it/il-cigno-di-vassalli-caso-editoriale-tra-cronaca-e-letteratura/